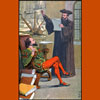|
Prefazione
di
Fernanda Mazzoli
È cosa insolita che un impiccato si congratuli per la propria sorte, ma nella vivace Lione della prima metà del XVI secolo – centro culturale di prima grandezza ove si ritrovarono alcune delle menti più brillanti dell’epoca – ciò poté avvenire grazie all’estro di Étienne Dolet, poeta umanista, editore di libri proibiti e libero pensatore, in breve un soggetto ideale per l’Inquisizione che il giorno del suo compleanno, 3 agosto 1546, gli offrì in dono un rogo allestito di tutto punto sulla piazza parigina di Maubert.
A differenza dei più celebri pendus di Villon che invocano la compassione degli altri uomini, poco inclini a riconoscere in loro dei frères humains, l’impiccato di questo componimento in latino di Dolet riconosce di avere avuto una singolare fortuna: il suo cadavere è stato oggetto di studio da parte del più grande medico del momento che ha potuto, grazie alle sue mortali spoglie, dimostrare l’armonia del corpo umano.
Il medico si chiamava François Rabelais, aveva già pubblicato le storie di Gargantua e Pantagruel e nel 1537 si era ritrovato a sezionare pubblicamente il cadavere di un impiccato, fornendo spiegazioni di carattere anatomico all’uditorio. Dopo gli studi di medicina a Montpellier, ove l’insegnamento univa la filosofia alla pratica sperimentale, nel 1532 François Rabelais era arrivato a Lione dove per alcuni anni aveva praticato la sua arte nell’ospedale cittadino, l’Hôtel Dieu du Pont du Rhône.
Medico e scrittore, combinò sapientemente i suoi diversi talenti, facendo della sua conoscenza della medicina la linfa vitale di un’opera romanzesca in cui il corpo umano figura come protagonista assoluto.
Se la sua genialità artistica ha fornito alla sua opera una fisionomia unica, è altrettanto vero, però, che questa doppia inclinazione non gli fu peculiare: furono numerosi gli umanisti che si interessarono di medicina, non ritenendola estranea alla loro riflessione sull’umana condizione.
Studiosi come Agrippa, o Cardano o Paracelso condussero le loro ricerche sotto il segno di una convergenza sostanziale fra medicina e filosofia, alimentata dall’idea di una corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo che supera l’assetto medievale del cosmo, orientato gerarchicamente verso l’alto.
Grande influenza sulla formazione medica di Rabelais fu esercitata dal Corpus Hippocraticum, raccolta in greco antico di scritti di diversa epoca, alcuni dei quali attribuibili ad Ippocrate ed altri a suoi seguaci.1
Nel 1532 aveva pubblicato e commentato gli aforismi di Ippocrate e di Galeno, le cui teorie erano allora tenute in grande considerazione e che lui, a differenza di altri dotti, leggeva nella lingua originale.
Da loro egli prese i principi fondamentali della sua concezione della malattia e della cura che traspose poi sul piano della creazione letteraria, dando vita ad un’originale idea di letteratura come forma terapeutica.
1 Si è occupato di anatomia nel Corpus Hippocraticum e del problema della vivisezione Enrico Crivellato nel suo recentissimo studio dedicato alle origini del pensiero anatomico nella cultura greca, La nascita del pensiero anatomico nella cultura greca. I poemi omerici. Gli scritti ippocratici, Petite Plaisance, Pistoia 2025.
|