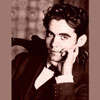|
|
Prologo antologico
«Il linguaggio è fatto a base di immagini, e il nostro popolo ne possiede una magnifica ricchezza. Chiamare alero [«grondaia», da «ala»] la parte sporgente del tetto è un’immagine magnifica; o chiamare un dolce tocino [«lardo»] del cielo o sospiri di suora sono altre immagini sicuramente molto graziose e molto acute; chiamare una cupola mezza arancia è un’altra immagine; e così via, all’infinito. In Andalusia l’immagine popolare arriva a gradi estremi di finezza e di sensibilità meravigliose, e le trasformazioni sono del tutto gongorine».
Da L’immagine poetica di Don Luis de Góngora,
conferenza pronunciata a Granada nel 1927.
«Perché una metafora abbia vita, ha bisogno di due condizioni essenziali: forma e raggio d’azione. Il suo nucleo centrale e un’ampia prospettiva intorno ad esso. Il nucleo si apre come un fiore che ci sorprende perché sconosciuto, ma nell’alone di luce che lo circonda troviamo il nome del fiore e riconosciamo il suo profumo. La metafora è sempre sostenuta dalla vista (a volte da una vista sublimata), ma è la vista a renderla limitata e a darle la sua realtà».
Ibidem.
«La vita di una mela, da quando è un fiore delicato fino a quando, dorata, cade dall’albero sull’erba, è altrettanto misteriosa e grande che il ritmo periodico delle maree. E un poeta deve sapere questo. La grandezza di una poesia non dipende dall’importanza del tema, né dalle sue proporzioni o dai sentimenti. Si può fare un poema epico sulla lotta che sostengono i leucociti nell’intreccio imprigionato delle vene, e si può dare un’indelebile impressione di infinito con la semplice forma e il profumo di una rosa».
Ibidem.
«Afferma il grande poeta francese Paul Valéry che lo stato di ispirazione non è lo stato adatto per scrivere una poesia. Siccome credo nell’ispirazione che Dio invia, credo che Valéry sia ben orientato. Lo stato di ispirazione è uno stato di raccoglimento, ma non di dinamismo creativo. Bisogna lasciare riposare la visione del concetto affinché si chiarisca. Non credo che nessun grande artista lavori in uno stato febbrile. Perfino i mistici lavorano quando ormai l’ineffabile colomba dello Spirito Santo abbandona le loro celle e si perde fra le nubi. Si ritorna dall’ispirazione come si ritorna da un paese straniero. Il poema è la narrazione del viaggio».
Ibidem.
«Tu non puoi immaginare cosa vuol dire passare notti intere alla finestra guardando una Granada notturna, vuota per me e senza ricavare la minima consolazione da nulla. E poi ... Cercando continuamente che il tuo stato d’animo non filtri nella tua poesia, perché essa ti giocherebbe il brutto scherzo di rivelare la zona più intimamente tua di fronte agli sguardi di coloro che non devono mai vederla».
Da una lettera del 1928
allo scrittore colombiano Jorge Zalamea.
«Ma l’immaginazione è limitata dalla realtà: non si può immaginare ciò che non esiste; l’immaginazione ha bisogno di oggetti, paesaggi, numeri, pianeti, e le relazioni tra di essi diventano necessarie all’interno della logica più pura. Non si può lanciarsi nell’abisso né prescindere dai termini reali. L’immaginazione ha orizzonti, vuole disegnare e concretare tutto quello che abbraccia».
Dalla conferenza
Immaginazione, ispirazione, evasione, del 1928.
«L’unica cosa che m’interessa è divertirmi, uscire, parlare per lunghe ore con amici, andare con le ragazze. Tutto quello che significhi godere la vita, ampia, piena, giovanile, bene intesa. L’ultima cosa, per me, è la letteratura. Tra l’altro, non mi propongo mai di farla. Solo che in certi periodi sento un’attrazione irresistibile che mi spinge a scrivere. Allora scrivo, per mesi, febbrilmente, per poi ritornare subito alla vita. Scrivere, senza dubbio, quando ci sono portato, mi procura un piacere. Invece, pubblicare, no. Proprio il contrario. Tutto quello che ho pubblicato mi è stato strappato da editori o da amici. A me piace recitare i miei versi, leggere le mie cose. Ma poi ho una grande paura della pubblicazione. Questo mi succede perché quando copio le mie cose comincio a trovarci dei difetti, decisamente non mi piacciono più. Ci sono dei versi miei che si sono diffusi prima di venire pubblicati. I miei libri mi sono stati strappati per forza. Mi basta dirvi che attualmente ho quattro libri di versi che non mi sono ancora deciso a pubblicare».
Da un’intervista pubblicata da
La Nación di Buenos Aires il 14 ottobre 1933.
«Vedrete voi stessi tutto lo spettacolo. In esso si valorizza il corpo umano, così trascurato nel teatro. Bisogna presentare la festa del corpo dalla punta dei piedi, in movimento di danza, fino alla punta dei capelli, il tutto presieduto dallo sguardo, interprete di ciò che sta dentro. Il corpo, la sua armonia, il suo ritmo, sono stati trascurati da quei signori che impiantano sulla scena personaggi con il cipiglio, seduti con il mento nella mano e che incutono paura fin dal primo momento. Bisogna rivalutare il corpo nello spettacolo. A questo io tendo».
Da un’intervista pubblicata su
Crítica di Buenos Aires il 15 dicembre 1933.
«Vi consiglio di ascoltare con attenzione questo grande poeta e di cercare di commuovervi insieme a lui ciascuno a suo modo. La poesia ha bisogno di una lunga iniziazione come qualsiasi sport, ma nella vera poesia c’è un profumo, un accento, un tratto luminoso che tutte le creature possono percepire. E chissà che vi serva per alimentare quel grano di pazzia che tutti portiamo dentro di noi, che molti uccidono per mettersi l’odioso monocolo della pedanteria libresca, e senza il quale è imprudente vivere».
Dalla presentazione di Pablo Neruda
fatta probabilmente nel 1934.
«Quando mi parlano della decadenza del teatro, io penso ai giovani autori drammatici che per colpa dell’attuale organizzazione della scena abbandonano il loro mondo di sogno e si dedicano a un’altra attività, stanchi di lottare: quando mi parlano della decadenza del teatro, io penso ai milioni di uomini che aspettano nelle campagne e nei quartieri popolari delle città di vedere con i loro occhi nuovi di meraviglia l’idillio con l’usignolo di Romeo e Giulietta, la pancia piena di vino di Falstaff o il lamento del nostro Sigismondo che lotta a viso aperto con il cielo. Non credo alla decadenza del teatro, come non credo alla decadenza della pittura o alla decadenza della musica.
Quando Mengs dipinge con colori pieni di paura e pennelli imputriditi dall’adulazione la corte di Carlo IV, arriva Goya che dipinge con le scarpe piene di fango, aggressivamente e senza mascherature, la faccia sciocca della duchessa di Medinaceli e il volto pagliaccesco del principe Fernando, che l’altro aveva rappresentato come Diana e Apollo. Quando gli impressionisti fanno dei paesaggi un impasto di luce, Cézanne innalza muri definitivi e dipinge mele eterne dove non penetrerà mai il verme intirizzito. Quando il rumore di Mozart diventa troppo angelico, appare come elemento di equilibrio il canto di Beethoven, troppo umano. Quando gli dèi di Wagner rendono smisurata l’espressione artistica, arriva Debussy a narrare l’epopea di un giglio sull’acqua. Quando l’eredità di immagini di Calderón de la Barca si riempie di mostri idioti e di espressioni contorte nei poetastri del secolo XVIII, arriva il flauto di Moratín, delizioso, fra quattro pareti, e quando la Francia si rinchiude troppo nelle sue stanze rivestite di seta, c’è una pioggia furiosa che si chiama Victor Hugo, che spezza i canapé con zampe di gazzella e riempie di alghe e manate gli specchi moribondi delle mensole».
Dal discorso pronunciato in occasione
della rappresentazione a Buenos Aires de La Niña Boba di Lope de Vega, pubblicato su Critica di Buenos Aires il 16 marzo 1934).
«Un popolo che non aiuta e non favorisce lo sviluppo del suo teatro, se non è morto, è moribondo; come il teatro che non raccoglie il palpito sociale, il palpito storico, il dramma delle sue genti e il colore autentico del suo paesaggio e del suo spirito, con le risate o con le lacrime, non ha il diritto di chiamarsi teatro, ma sala da gioco o luogo per fare quella cosa orribile che si chiama “ammazzare il tempo”. Non mi riferisco a nessuno e non voglio offendere nessuno; non parlo della realtà viva, ma del problema impostato senza offrire una soluzione.
Io sento tutti i giorni, miei cari amici, parlare della crisi del teatro, e penso sempre che il male non sta davanti ai nostri 24 Prologo antologico
occhi, ma negli aspetti più oscuri della sua essenza; non è un male di origine attuale, legato alle opere, ma ha radici profonde, è insomma un male che deriva dall’organizzazione. Finché attori e autori saranno nelle mani di imprese del tutto commerciali, libere e senza controllo letterario o statale di nessun genere, imprese prive di ogni criterio e senza nessun tipo di garanzie, gli attori, gli autori e l’intero teatro sprofonderanno ogni giorno di più, senza possibilità di salvezza».
Dal discorso sul teatro pronunciato il 14 agosto 1934
all’Università Internazionale di Santander.
«Ho imparato dal maestro Falla, che oltre a essere un grande artista è un santo, una lezione esemplare. In numerose occasioni egli è solito dire: “Noi che facciamo questo mestiere di musicisti”. Queste parole umili e magnifiche le ascoltò un giorno dalle labbra del maestro la pianista Wanda Landowska e le parvero un’eresia. Ci sono artisti che credono, per il solo fatto di essere tali, di avere bisogno di originalità in ogni loro manifestazione. “All’artista deve essere permesso tutto, ecc.”. Io sono d’accordo con Falla. La poesia è come un dono. Io faccio il mio mestiere e assolvo ai miei obblighi, senza fretta, perché soprattutto quando si sta per terminare un’opera, come se dicessimo quando si sta per mettere il tetto, è un piacere enorme lavorare a poco a poco».
Da un’intervista pubblicata su
El Sol di Madrid del 15 dicembre 1934.
«Si dica pure quel che si vuole, ma il teatro non è in decadenza. Gli aspetti assurdi e decadenti si trovano nella sua organizzazione. Il fatto che un signore, solo perché dispone di alcuni milioni, si atteggi a censore di opere e a sovrano del teatro, è intollerabile e vergognoso. È una tirannide che, come tutte, può condurre solo al disastro. [...] A questo mondo io sono e sarò sempre dalla parte dei poveri. Io sarò sempre dalla parte di quelli che non hanno nulla e ai quali si nega perfino la tranquillità di questo nulla. Noi – mi riferisco agli uomini di un certo livello intellettuale, educati nell’ambiente delle classi che possiamo definire agiate – siamo chiamati al sacrificio. Nel mondo la lotta non avviene più tra forze umane ma tra forze telluriche. Mi presentano su una bilancia il risultato di questa lotta: da una parte il tuo dolore e il tuo sacrificio, dall’altra la giustizia per tutti, sia pure con l’angoscia della transizione verso un futuro che si intuisce, ma che si ignora, e io scarico il pugno con tutte le mie forze su quest’ultimo piatto».
Ibidem.
«Ma al disopra di questa statua aerea io voglio mettere il suo sangue come un ramo di corallo, agitato dalla marea, i suoi nervi identici alla fotografia di un gruppo di fulmini, la sua testa di minotauro, dove la neve gongorina è rappresentata da un volo di colibrí, i suoi occhi vaghi e assenti di milionario di lacrime, e anche i suoi difetti. Gli scaffali ormai divorati dai tarli, dove risuonano vuoti di flauto, le bottiglie di cognac della sua drammatica ubriachezza, e il suo incantevole cattivo gusto, e le sue zeppe sfacciate che riempiono di umanità la pletora dei suoi versi. Al di fuori di norme, forme e scuole rimane valida la sostanza feconda della sua grande poesia».
Dalla celebrazione di Rubén Darío, tenuta insieme a Pablo Neruda, attraverso un discorso “al alimón” [corrida con due toreri], pubblicato su El Sol di Madrid il 30 dicembre 1934.
«Di fronte a un pubblico ho sempre una certa esitazione a leggere dei versi, perché la poesia è tutto il contrario dell’oratoria. Nell’oratoria, l’oratore svolge un’idea già conosciuta dal pubblico e la rigira da ogni parte con un gioco scontato che la folla accoglie con entusiasmo, è come una lunga bandiera che l’oratore fa giocare con il vento, cambiando le pieghe, ma senza alterarne le linee; in poesia bisogna stare attenti a captare immagini e sentimenti che escono polverizzati come l’acqua di una tempesta e in tutte le direzioni come uno stormo di uccelli spaventati dallo sparo del cacciatore».
Dalle parole preliminari a un recital di poesie, pubblicate su
La Rambla de Catalunya di Barcellona, il 7 ottobre 1935.
«La poesia è qualcosa che cammina per le strade. Che si muove, che passa accanto a noi. Tutte le cose hanno il loro mistero, e la poesia è il mistero che hanno tutte le cose. Si passa accanto a un uomo, si guarda una donna, si percepisce l’incedere obliquo di un cane, e in ciascuno di questi oggetti umani c’è la poesia».
Da un’intervista realizzata da Felipe Morales,
pubblicata su La Voz di Madrid il 7 aprile 1936.
«Il teatro è sempre stato la mia vocazione. Ho dato al teatro molte ore della mia vita. Ho un concetto del teatro in un certo senso personale e convincente. Il teatro è la poesia che si solleva dal libro e diventa umana. E mentre lo diventa, parla e grida, piange e si dispera. Il teatro richiede che i personaggi che compaiono sulla scena portino un vestito di poesia e che nello stesso tempo si vedano le loro ossa, il loro sangue. Devono essere così umani, così orribilmente tragici e legati alla vita e alla giornata con una forza tale, da mostrare i loro tradimenti, da permettere che si avvertano i loro odori e che esca dalle loro labbra tutto il vigore delle loro parole piene d’amore o di schifo. Ciò che non può proseguire è la sopravvivenza dei personaggi drammatici che oggi salgono sulle scene condotti per mano dai loro autori. Sono personaggi evanescenti, del tutto vuoti, ai quali si può vedere attraverso il gilé solo un orologio fermo, un osso falso o uno sterco di gatto di quelli che ci sono nelle soffitte. Oggi in Spagna la maggioranza degli autori e degli attori occupano una zona appena intermedia. A teatro si scrive per i posti di prima fila e si lasciano insoddisfatti il settore dei secondi posti e il loggione. Scrivere per i posti di prima fila è la cosa più triste del mondo. Il pubblico che va agli spettacoli rimane defraudato. E il pubblico vergine, il pubblico ingenuo, che è il popolo, non capisce perché gli si parla di problemi da esso disprezzati nei cortili del vicinato. In parte la colpa ce l’hanno gli attori. Non che siano delle cattive persone, ma ... “Senta, Tizio – e qui un nome di autore –, voglio che lei mi scriva una commedia in cui io ... sia proprio io. Sì, sì; io voglio fare questo e quello. Voglio inaugurare un vestito primaverile. Mi piace avere ventitré anni. Non lo dimentichi”. E così non si può fare del teatro. In questo modo si può solo perpetuare una giovane dama attraverso il tempo e un dongiovanni nonostante l’arteriosclerosi».
Ibidem.
«[…] devo dire che questo concetto dell’arte per l’arte è una cosa che sarebbe crudele se per fortuna non fosse pacchiana. Nessun vero uomo crede più a questa stupidaggine dell’arte pura, dell’arte per l’arte stessa. In questo momento drammatico del mondo, l’artista deve piangere e ridere insieme al suo popolo. Bisogna abbandonare il ramo di gigli ed entrare nel fango fino alla cintola per aiutare quelli che cercano i gigli. In particolare io sento una vera e propria ansia di comunicare con gli altri. Per questo ho bussato alle porte del teatro e al teatro dedico tutta la mia sensibilità».
Da una conversazione con il disegnatore Bagaría
pubblicata su El Sol di Madrid il 10 giugno 1936.
|