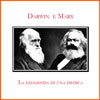|
|
Prefazione
È degno di riflessione che Marx ebbe sempre un interesse vivo, costante, mai episodico e saltuario, per i progressi che si stavano facendo nelle scienze naturali ed applicate. Questo interesse non era fondato sul progetto di “incorporazione” della propria scoperta (il materialismo storico come teoria della genesi, sviluppo e declino di determinati modi di produzione, in particolare quello capitalistico) in un’enciclopedia generale delle scienze di tipo positivistico, ma si basava su di una acuta consapevolezza di tipo interdisciplinare, ostile a quella esasperata divisione accademico-universitaria delle discipline che fu un prodotto (spesso non voluto, ed anzi avversato a parole) del grande positivismo europeo dell’Ottocento.
Il materialismo storico restava in Marx qualcosa di ben distinto dalla chimica, fisica, biologia, mineralogia, geografia, ecc. Esso aveva il suo oggetto ed il suo metodo peculiare, ma il suo sviluppo sarebbe risultato asfittico e monco, senza una ricca e consapevole informazione nel campo delle scienze della natura e dell’industria.1 Marx stesso si impegnò a fondo in questo campo, e questo impegno comportò necessariamente l’uso e l’abuso di metafore di tipo naturalistico, deterministico e scientistico tipiche del linguaggio delle scienze della natura del tempo, basate sul paradigma della necessità, categoria assolutamente portante di tutto il linguaggio scientifico dell’Ottocento.2
L’ideale laplaciano, rigorosamente deterministico e necessitaristico, è infatti centrale, nell’Ottocento, non tanto nelle singole scienze particolari (le quali, come ben spiega Gaston Bachelard, avevano tempi di sviluppo ben differenziati e problemi specifici di “assestamento epistemologico” non suscettibili di essere semplificati e ridotti ad un unico modello), quanto nella “ricaduta filosofica” con la quale le scienze “si presentavano” alla sintesi culturale dominante. Questo non significa, ovviamente, che la storia delle scienze dall’Ottocento al Novecento sia stata un semplice trapasso dalle “sicurezze” predittive e deterministiche ad una sorta di generale indeterminismo (sarebbe, questa, una vera caricatura della storia del pensiero scientifico).
È invece possibile dire, con tutta tranquillità, che la categoria di necessità aveva un ruolo assolutamente centrale nell’immagine della scienza ottocentesca, finendo inoltre con l’indicare due significati del tutto eterogenei l’un l’altro, il nesso di causalità rigorosa, da un lato, la ferrea prevedibilità ed anticipazione degli esiti, dall’altro. Qui sta, fra l’altro, la radice di quell’equivoco (filosoficamente assai poco spiegabile), tanto diffuso soprattutto a fine Ottocento, che faceva dell’ideale scientifico qualcosa di simultaneamente meccanicistico (basato cioè su di una causalità rigorosamente necessitante) e teleologico (in grado di prevedere, cioè, un esito in modo talmente infallibile da far pensare che questo esito fosse stato iscritto fin da principio nella “natura stessa” del fenomeno).3
La paradossale compresenza di meccanicismo e di teleologismo, tipica dell’immagine scientifica ottocentesca (che era poi l’immagine che giungeva allo stesso Marx), permette di comprendere la sostanziale inutilità di tutti quegli schemi di lettura (alla Lucio Colletti, per intenderci) che retrodatano all’Ottocento la contrapposizione polare fra intelletto scientifico-analitico, buono, e ragione dialettico-contraddittoria, cattiva. Il necessitarismo teleologico era infatti presente (ed anzi, fortemente presente) sia nelle teorie scientifiche di tipo rigorosamente empirico-induttivo sia nelle generalizzazioni enciclopediche di tipo dialettico, senza che fosse possibile una netta separazione fra le due.4
Anche Marx, ovviamente, è spesso irresistibilmente attratto da questa compresenza di meccanicismo e di teleologismo, e talvolta, mette egli stesso il materialismo storico e la critica dell’economia politica sotto il dominio della categoria della necessità (mettendo fra parentesi tutte le altre categorie ontologiche, in primo luogo la categoria della possibilità).5 Ciò non deve stupire, e nemmeno scandalizzare: ciò che invece stupisce, e sinceramente scandalizza, è il ritardo del materialismo storico a cent’anni dalla morte di Marx a “sganciarsi” da un paradigma scientifico ottocentesco, superato ormai da molto tempo.
Il ritardo è caratteristico anche della storiografia e della cosiddetta marxologia. Ingenera stupore e sdegno, ad esempio, il permanere della leggenda che vuole Marx mendicare, alla porta della casa di Darwin, il permesso di dedicare Il Capitale al grande naturalista.6 Marx ammirava infatti moltissimo Darwin, ma non ne feticizzò mai il metodo, in primo luogo, e non attribuì mai al darwinismo teorico una natura teleologico-metafisica, in secondo luogo (quasi volesse “legittimare” una lettura teleologico-deterministica della propria opera assimilandola a quella darwiniana). Marx non permise mai alla propria autoconsapevolezza scientifica l’irruzione di una immagine teleologico-necessitante della propria concezione dell’accumulazione del capitale (così come non permise mai un’antropomorfizzazione filosofico-idealistica del ruolo storico del Proletariato), nonostante alcune evidenti concessioni all’immagine ottocentesca della scienza. Impedì questo la sua consapevolezza filosofica di tipo ontologico-sociale, cui ora brevemente accenneremo.
1 Un’opera preziosa è in proposito quella di A. Guerraggio e F. Vidoni, Nel laboratorio di Marx: scienze naturali e matematica, Franco Angeli, Milano 1982. Questa puntuale analisi dell’articolazione complessiva degli interessi ed interventi scientifici di Marx giunge a conclusioni assolutamente anti-scientistiche, e che tendono a superare l’assurda contrapposizione fra una Marx “umanistico” ed un Marx “scientifico”. Guerraggio e Vidoni (op. cit., pp. 55-61) chiariscono come Marx, che ha pure postulato la possibile edificazione futura di una sorta di unica scienza (capace di unificare natura e società) non è andato di fatto oltre un uso metaforico di questa espressione. La nozione di «storia naturale» (che Marx usa talvolta anche per la storia umano-sociale) deriva invece da un uso illuministico e settecentesco, sorto in polemica con le concezioni provvidenzialistiche e metafisiche (sia della natura che della storia), e non connota affatto meccanicamente una (indebita) naturalizzazione scientistica del mondo storico e sociale. Si tratta di una precisazione “semantica” di grandissimo significato anche teorico.
2 Il fondamentale libro di S.S. Prawer (cfr. La biblioteca di Marx, Garzanti, Milano 1978) ci aiuta a comprendere il “processo di produzione” della prosa marxiana (edita ed inedita) a partire dalla sua conoscenza della letteratura mondiale, classica e moderna, ma non parla delle metafore scientifiche, e deve perciò essere integrato con il libro di Guerraggio e Vidoni (di cui alla nota precedente).
3 È utile, in proposito, una conoscenza della “crisi dei fondamenti” della scienza ottocentesca, così come si manifestò a cavallo dei due secoli. Del tutto fuorvianti sono invece le letture che enfatizzano la rottura fino al punto di evocare un “cominciamento assoluto delle scienze” nel Novecento, come se gli uomini dell’Ottocento fossero stati del tutto privi della consapevolezza della problematicità di un paradigma troppo rigidamente necessitaristico. Si evocano così “crisi della ragione” che sono quasi sempre pretesti per liquidare il “materialismo storico” in nome della liquidazione dei paradigmi necessitaristici ottocenteschi.
4 La teoria darwiniana dell’evoluzione (nient’affatto “dialettica”, ed aliena da ogni utilizzo della “contraddizione”) era notoriamente recepita in chiave teleologico-necessitaristica (e viene ancora oggi raffigurata nei posters didattici come una “catena evolutiva ascendente” dal magma vulcanico all’uomo bianco dalla fronte spaziosa). D’altra parte, nonostante la fastidiosa “leggenda” collettiana, la dialettica non incorpora affatto un teleologismo necessitaristico e non è affatto in “contraddizione” con la logica aristotelica (si veda, per cominciare, la voce Dialettica di E. Rambaldi per la Enciclopedia Einaudi, ed ancor meglio quel piccolo capolavoro di chiarezza, competenza intellettuale ed informazione di E. Berti, Logica aristotelica e dialettica, Cappelli, Bologna 1983). È peraltro vero (cfr. E. Berti, op. cit., p. 48) che in Marx, accanto ad una sostanziale accettazione del principio aristotelico di non contraddizione, sono presenti tendenze a ritenere la “realtà contraddittoria” fatalmente destinata a “morire” con l’esplosione di questa stessa contraddizione.
5 Si veda H. Fleischer, Marxismo e storia, il Mulino, Milano 1970. Con grande chiarezza e sobrietà Fleischer analizza dettagliatamente la nozione di “necessità storica”, con osservazioni penetranti anche sul cosiddetto “determinismo economico”. In piena sintonia con l’ultimo Bloch e con l’ultimo Lukàcs egli rifiuta l’interpretazione deterministica del marxismo contenuta nella frase «la libertà non è che coscienza della necessità».
6 Questa leggenda è stata definitivamente sfatata da M. Fay, una leggenda che fu coltivata per suggerire un’analogia fra il progetto teorico marxiano e quello darwiniano, ma i fatti sono altri, come qui di seguito potrete leggere.
Costanzo Preve
|