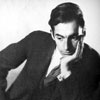|
|
Prologo antologico
«Ho intrapreso la più grande uscita da me stesso: la creazione, volendo illuminare le parole. Dieci anni di lavoro solitario, che fanno esattamente la metà della mia vita, hanno fatto in modo che si succedessero nella mia espressione ritmi diversi, correnti contrarie. Legandole, intrecciandole, senza trovare l’elemento durevole, perché non esiste, ecco Venti poesie d’amore e una canzone disperata. Disperse come il pensiero nelle sue inafferrabili mutazioni, allegre e amare, io le ho fatte e ho provato della sofferenza nel farle. Ho cantato soltanto la mia vita e l’amore di alcune donne amate, come chi comincia col salutare a grandi grida la parte più vicina del mondo.
Ho cercato di unire sempre più l’espressione al mio pensiero e ho ottenuto qualche vittoria: mi sono messo in ogni cosa che è uscita da me, con sincerità e volontà. Senza esitare, persone rispettabili e sconosciute – non impiegati e pedagoghi che mi detestano personalmente – mi hanno mostrato i loro gesti cordiali, da lontano. Senza dare loro importanza, concentrando le mie forze per arrestare la marea, non ho fatto altro che dare intensità al mio lavoro. Non mi sono stancato di nessuna disciplina perché non l’ho mai avuta: la roba usata che agli altri va bene risultò per me piccola o grande, e la riconobbi senza guardarla. Buon meditatore, durante la mia vita ho dato ospitalità a troppe inquietudini perché queste passassero di colpo attraverso ciò che scrivo. Senza guardare verso nessuna direzione, liberamente, incontenibilmente, mi si sciolsero le mie poesie».
Esegesi e solitudine
(pubblicato il 20 agosto 1924
sul quotidiano La Nación di Santiago).
«Io prediligo sempre le grandi idee, e benché la letteratura mi si offra con grandi vacillazioni e dubbi, preferisco non fare nulla piuttosto di scrivere ballabili o divertimenti.
Io ho un concetto drammatico della vita, e romantico; non mi si addice ciò che non arriva in maniera profonda alla mia sensibilità. Per me è stato molto difficile unire questa costante del mio spirito con un’espressione più o meno adeguata. Nel mio secondo libro Venti poesie d’amore e una canzone disperata ho ottenuto qualche risultato nel senso di un lavoro trionfante. Questa gioia di bastare a se stesso non la possono conoscere gli equilibrati imbecilli che fanno parte della nostra vita letteraria.
Come cittadino, sono un uomo tranquillo, nemico di leggi, governi e autorità costituite. Provo ripugnanza per il borghese, e mi piace la vita della gente inquieta e insoddisfatta, siano essi artisti o criminali».
Dalla prefazione dell’autore
alla prima edizione di
L’abitante e la sua speranza, 1926.
«È molto utile, in certe ore del giorno o della notte, osservare profondamente gli oggetti in riposo: le ruote che hanno percorso lunghe, polverose distanze, sopportando grossi carichi vegetali o minerali, i sacchi delle botteghe dei carbonai, i barili, le ceste, i manici degli strumenti del falegname. Da essi si sprigiona il contatto tra l’uomo e la terra come una lezione per il tormentato poeta lirico. Le superfici usate, il logorio che le mani hanno inflitto alle cose, l’atmosfera spesso tragica e sempre patetica di questi oggetti, infonde una sorta di attrazione non disprezzabile verso la realtà del mondo.
L’impurità confusa degli esseri umani si coglie in essi, il raggruppamento, l’uso e il non uso dei materiali, le orme del piede e delle dita, la costanza di un’atmosfera umana che inonda le cose dall’interno e dall’esterno.
Così sia la poesia che cerchiamo, consunta come da un acido dai doveri della mano, impregnata di sudore e di fumo, odorante di urina e di giglio, cosparsa dalle diverse professioni che si esercitano dentro e fuori della legge.
Una poesia impura come un vestito, come un corpo, con macchie di cibo, e atteggiamenti sconci, con rughe, osservazioni, sogni, veglie, profezie, dichiarazioni d’amore e di odio, bestie, scosse, idilli, convinzioni politiche, negazioni, dubbi, affermazioni, tasse.
La sacra legge del madrigale e i decreti del tatto, dell’olfatto, del gusto, della vista, dell’udito, il desiderio di giustizia, il desiderio sessuale, il rumore dell’oceano, senza escludere deliberatamente nulla, senza accettare deliberatamente nulla, l’introduzione nella profondità delle cose con un atto di violento amore, e il prodotto poesia macchiato di colombe digitali, con impronte di denti e di ghiaccio, forse corroso leggermente dal sudore e dall’uso. Fino a raggiungere quella dolce superficie dello strumento suonato senza posa, quella morbidezza durissima del legno maneggiato, dell’orgoglioso ferro. Il fiore, il grano, l’acqua hanno anch’essi quella consistenza particolare, quella risorsa di un magnifico tatto.
E non dimentichiamo mai la malinconia, il sentimentalismo logoro, perfetti frutti impuri di meravigliosa qualità dimenticata, lasciati in disparte dalla frenesia libresca: la luce della luna, il cigno all’imbrunire, “cuore mio” sono indubbiamente l’elemento poetico primordiale e imprescindibile. Chi rifugge dal cattivo gusto cade nel gelo».
Su una poesia senza purezza
(Editoriale del n. 1, ottobre 1935,
della rivista «Caballo verde para la poesía»).
«Verso la strada del notturno protende le dita la grave statua ferrea dalla statura implacabile. I canti senza consultazione, le manifestazioni del cuore corrono con ansia al loro dominio: la poderosa stella polare, la violaciocca planetaria, le grandi ombre invadono l’azzurro.
Lo spazio, la grandezza ferita si avvicinano. Non li frequentano i figli miserabili delle capacità e del tempo al tempo. Mentre l’infinita lucciola riduce in polvere ardente la sua coda fosforica, gli studenti della terra, i geografi sicuri, gli impresari si decidono a dormire. Gli avvocati, i destinatari.
Solo soltanto qualche cacciatore imprigionato In mezzo ai boschi, oppresso da alluminio celestiale: stellato da stelle furiose, solennemente solleva la mano inguantata e si batte il posto del cuore.
Il posto del cuore ci appartiene. Solo soltanto di lì, con l’aiuto della notte nera, dell’autunno deserto, escono, sotto i colpi della mano, i canti del cuore.
Come lava o tenebre, come tremito bestiale, come rintocco senza direzione, la poesia mette le mani nella paura, nelle angosce, nelle malattie del cuore. Sempre esistono fuori le grandi decorazioni che impongono la solitudine e l’oblio: alberi, stelle. Il poeta vestito a lutto scrive con trepidazione molto solitario».
I temi
(Editoriale del n. 2, novembre 1935,
della rivista «Caballo verde para la poesía»).
«Quando il tempo ci va divorando con il suo quotidiano decisivo lampo, e gli atteggiamenti fondati, le fiducie, la fede cieca si precipitano e l’elevazione del poeta tende a cadere come la più triste madreperla sputacchiata ci chiediamo se è giunta ormai l’ora di abbrutirci.
La dolorosa ora di guardare come si sostiene l’uomo coi soli denti, con le sole unghie, coi soli interessi. E come entrano nella casa della poesia i denti e le unghie e i rami del feroce albero dell’odio.
È il potere dell’età o è, forse, l’inerzia che fa retrocedere i frutti sull’orlo stesso del cuore, o forse l’artisticità s’impadronisce del poeta e invece del canto salubre che le onde profonde devono far saltare, vediamo ogni giorno il miserabile essere umano difendere il suo miserabile tesoro di persona preferita?
Ahimè, il tempo avanza con cenere, con aria e con acqua! La pietra che hanno morso il fango e l’angoscia fiorisce all’improvviso con fragore di mare, e la piccola rosa ritorna alla sua delicata tomba di corolla. Il tempo lava e svolge, ordina e continua.
E allora, cosa rimane delle piccole putrefazioni, delle piccole cospirazioni del silenzio, dei piccoli freddi sporchi dell’ostilità? Nulla, e nella casa della poesia non rimane nulla al di fuori di ciò che fu scritto col sangue per essere ascoltato dal sangue».
Condotta e poesia
(Editoriale del n. 3, dicembre 1935,
della rivista «Caballo verde para la poesía»).
«Forse a nessuno in queste terre è toccato in sorte di scatenare tante invidie come alla mia persona letteraria. C’è della gente che vive di questa professione, di invidiarmi, di farmi una strana pubblicità, per mezzo di libelli contorti o tenaci e di riviste pittoresche.
Ho perso nel corso dei miei viaggi questa singolare raccolta. I piccoli pamphlets sono rimasti in stanze lontane, sotto altri climi. In Cile riempio di nuovo la mia valigia con questa lebbra endemica e fosforescente, metto da parte di nuovo gli aggettivi viziosi che vogliono assassinarmi. Da altre parti queste cose non mi succedono. E tuttavia ritorno. Il fatto è che mi piace ciecamente la mia terra, e tutto il sapore verde e amaro del suo cielo e del suo fango. E l’amore che mi tocca mi piace di più qui, e questo odio stravagante e mistico che mi circonda mette nella mia proprietà un fecondo e necessario escremento. Non di sole stelle vive l’uomo.
La Spagna, quando misi i piedi sul suo suolo, mi diede tutte le mani dei suoi poeti, dei suoi leali poeti, e con loro divisi il pane e il vino, nell’amicizia categorica del centro della mia vita. Ho il ricordo vivo di quelle prime ore o anni di Spagna, e spesso sento la mancanza dell’affetto dei miei compagni».
Da Amicizie e inimicizie letterarie
(pubblicato sulla rivista
«Qué hubo» di Santiago, 20 aprile 1940).
«La prima età di un poeta deve raccogliere con attenzione appassionata le essenze della sua patria, e deve poi restituirle. Deve ricostruirle, deve donarle. Il suo canto e la sua azione devono contribuire alla maturazione e alla crescita del suo popolo.
Il poeta non può essere sradicato, se non con la forza. Anche in queste circostanze le sue radici devono attraversare il fondo del mare, i suoi semi devono seguire il volo del vento, per incarnarsi, ancora una volta, nella sua terra.
Deve essere deliberatamente nazionale, riflessivamente nazionale, maturamente patrio.
Il poeta non è una pietra smarrita. Ha due obblighi sacri: partire e ritornare. Il poeta che parte e non ritorna è un cosmopolita. Un cosmopolita è appena un uomo, è appena un riflesso della luce moribonda. Soprattutto in queste patrie solitarie, isolate tra le rughe del pianeta, testimoni integrali dei primi segni dei nostri popoli, tutti, tutti dai più umili ai più orgogliosi, abbiamo la fortuna di andare creando la nostra patria, di essere tutti un po’ suoi padri».
Dal discorso pronunciato in occasione dell’inaugurazione della
Fondazione Neruda per lo studio della Poesia,
a Santiago, il 20 giugno 1954.23 Prologo antologico
«Andando molti anni fa per il lago Ranco verso l’interno mi sembrò di trovare la fonte della patria o la culla silvestre della Poesia, attaccata e difesa da tutta la natura.
Il cielo si stagliava tra le superbe chiome dei cipressi, l’aria agitava le sostanze balsamiche della macchia, tutto aveva voce ed era silenzio, il sussurro degli uccelli nascosti, i frutti e gli stecchi che cadendo sfioravano il fogliame, tutto stava sospeso in un istante di solennità segreta, tutto nella selva sembrava aspettare.
Era imminente una nascita e quello che nasceva era un fiume. Non so come si chiama, ma le sue prime acque, vergini e oscure, erano quasi invisibili, deboli e silenziose, cercando un’uscita in mezzo ai grandi tronchi morti e alle pietre colossali.
Mille anni di foglie cadute nella sua sorgente, tutto il passato voleva trattenerlo, ma imbalsamava soltanto la sua strada. Il giovane fiume distruggeva le vecchie foglie morte e si impregnava di freschezza nutritiva che sarebbe andato ripartendo nel corso del suo cammino.
Io pensai: è così che nasce la poesia. Viene da altezze invisibili, è segreta e oscura nelle sue origini, solitaria e fragrante, e, come il fiume, dissolverà tutto quello che cade nella sua corrente, cercherà una strada tra le montagne e scuoterà il suo manto cristallino nelle praterie.
Irrigherà i campi e darà pane all’affamato. Camminerà tra le spighe. Sazieranno in essa la loro sete i viandanti e canterà quando lottano o riposano gli uomini.
E li unirà allora e tra di loro passerà, fondando paesi. Taglierà le vallate portando alle radici la moltiplicazione della vita.
Canto e fecondazione è la poesia.
Ha lasciato le sue viscere segrete e corre fecondando e cantando. Accende l’energia con il suo movimento accresciuto, lavora producendo farina, conciando il cuoio, tagliando il legno, dando luce alle città. È utile e si risveglia con bandiere ai suoi margini. Le feste si celebrano accanto all’acqua che canta.
Mi ricordo a Firenze un giorno in cui andai a visitare una fabbrica. Vi lessi alcune mie poesie agli operai riuniti, le lessi con tutto il pudore che un uomo del continente giovane può provare parlando accanto all’ombra sacra che lì sopravvive. Gli operai della fabbrica mi fecero poi un regalo. Lo conservo ancora. È un’edizione del Petrarca dell’anno 1484. La poesia era passata con le sue acque, aveva cantato in quella fabbrica e aveva convissuto per secoli con i lavoratori. Quel Petrarca, che vidi sempre imbacuccato sotto un cappuccio da monaco, era uno di quei semplici italiani e quel libro, che presi nelle mie mani con adorazione, assunse per me un nuovo prestigio, era solo un arnese divino nelle mani dell’uomo».
Dal discorso pronunciato a Santiago
il 12 luglio del 1954, in occasione del 50° anniversario
dell’Università del Cile.
«Sincerità, in questa parola così modesta, così arretrata, così calpestata e disprezzata dal seguito sfavillante che accompagna eroticamente l’estetica, si trova forse definita la mia azione costante.
Ma semplicità non significa un abbandono semplicistico all’emozione o alla conoscenza.
Quando rifuggii prima per vocazione e poi per decisione qualsiasi posizione di maestro letterario, ogni ambiguità esteriore che mi avrebbe esposto al rischio continuo di esteriorizzare, e non di costruire, compresi in maniera vaga che il mio lavoro doveva prodursi in forma così organica e totale che la mia poesia fosse come la mia stessa respirazione, prodotto ritmato della mia esistenza, risultato della mia crescita naturale. Per questo, se qualche lezione proveniva da un’opera così intimamente e così oscuramente legata al mio essere, questa lezione avrebbe potuto essere sfruttata al di là della mia azione, al di là della mia attività, e soltanto attraverso il mio silenzio.
Sono uscito in strada durante tutti questi anni, disposto a difendere principi di solidarietà con uomini e con popoli, ma la mia poesia non ha potuto essere insegnata a nessuno. Volli che si diluisse sulla mia terra, come le piogge delle mie latitudini natali. Non ho preteso che frequentasse cenacoli o accademie, non l’ho imposta a giovani emigranti, l’ho concentrata come prodotto vitale della mia stessa esperienza, dei miei sensi che rimasero aperti all’estensione dell’amore ardente e del mondo spazioso. Non pretendo per me nessun privilegio di solitudine: non l’ebbi se non quando mi fu imposta come condizione terribile della mia vita. E allora scrissi i miei libri, come li scrissi circondato dalla folla adorabile, dall’infinita e ricca moltitudine dell’uomo. Né la solitudine né la società possono alterare i requisiti del poeta e quelli che si richiamano esclusivamente all’una o all’altra falsificano la loro condizione di api che costruiscono da secoli la stessa cellula fragrante, con lo stesso alimento di cui ha bisogno il cuore umano. Tuttavia, non condanno né i poeti della solitudine né gli altoparlanti del grido collettivo: il silenzio, il suono, la separazione e l’integrazione degli uomini, tutto è materiale adeguato affinché le sillabe della poesia si aggreghino precipitando la combustione di un fuoco incancellabile, di una comunicazione inerente, di un’eredità sacra che da migliaia di anni si traduce nella parola e si innalza nel canto».
Da Latorre, Prado e la mia stessa ombra
(Discorso pronunciato all’Università del Cile
il 30 marzo 1962).
«La poesia è sempre un atto di pace. Il poeta nasce dalla pace come il pane nasce dalla farina.
Gli incendiari, i guerrieri, i lupi cercano il poeta per bruciarlo, per ucciderlo, per morderlo. Uno spadaccino lasciò Puskin ferito a morte in mezzo agli alberi di un cupo parco. I cavalli di polvere galopparono impazziti sul corpo senza vita di Petöfi. Lottando contro la guerra, morì Byron in Grecia. I fascisti spagnoli iniziarono la guerra in Spagna assassinando il suo poeta migliore.
Rafael Alberti è una sorta di sopravvissuto. C’erano mille morti preparate per lui. Una anche a Granada. Un’altra morte l’aspettava a Badajoz. A Siviglia piena di sole o nella sua piccola patria, Cadice e Puerto Santa María, là lo cercavano per accoltellarlo, per impiccarlo, per uccidere in lui ancora una volta la poesia.
Ma la poesia non è morta, ha le sette vite del gatto. L’offendono, la trascinano per strada, le sputano addosso e la scherniscono, l’assediano per soffocarla, l’esiliano, l’imprigionano, le sparano quattro colpi ed essa esce da tutte queste vicende con la faccia lavata e un sorriso luminoso come il riso».
Da Confieso que he vivido. Memorias,
Buenos Aires, Losada, 1974, pp. 187-188.
«Il lavoro degli scrittori, io dico, ha molto in comune con quello dei pescatori artici. Lo scrittore deve cercare il fiume e, se lo trova gelato, deve perforare il ghiaccio. Deve avere pazienza da sprecare, sopportare le intemperie e la critica ostile, sfidare il ridicolo, cercare la corrente profonda, lanciare l’amo giusto, e dopo tanti e tanti lavori tirare su un pesciolino piccino. Ma deve tornare a pescare, contro il freddo, contro il ghiaccio, contro l’acqua, contro il critico, fino a raccogliere una pesca sempre più ricca».
Ibidem, p. 273.
«La poesia ha perduto il suo legame con il lettore lontano ... Deve recuperarlo ... Deve camminare nell’oscurità e incontrarsi con il cuore dell’uomo, con gli occhi della donna, con gli sconosciuti delle strade, di quelli che a una certa ora del crepuscolo, o in piena notte stellata, hanno bisogno sia pure di un solo verso ... Questa visita imprevista vale tutto quanto si è camminato, si è letto, si è imparato ... Bisogna perdersi tra quelli che non conosciamo perché a un tratto raccolgano le nostre cose dalla strada, dalla sabbia, dalle foglie cadute per mille anni nello stesso bosco ... e prendano teneramente quest’oggetto che abbiamo fatto noi ... Solo allora saremo veramente poeti ... In quest’oggetto vivrà la poesia ...».
Ibidem, p. 354.
«Il poeta che non sia realista è morto. Ma il poeta che sia solo realista è altrettanto morto. Il poeta che sia solo irrazionale sarà colpito solo da se stesso e dalla sua amata, e ciò è abbastanza triste. Il poeta che sia solo razionalista, sarà colpito perfino dagli asini, il che è pure sommamente triste. Per equazioni di questo tipo non ci sono cifre sul pallottoliere, non ci sono ingredienti decretati da Dio o dal diavolo, ma questi due personaggi importantissimi conducono una lotta contro la poesia, e in questa battaglia vince l’uno e vince l’altro, ma la poesia non può venite sconfitta».
Ibidem, p. 361.
|