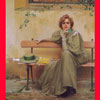|
|
Introduzione
Perché la letteratura e perché i classici.
Un necessario discorso preliminare
Solo per questa ragione le grandi opere hanno qualcosa da dire a tutti i tempi e precisamente un novum che seguita a indirizzare oltre e che le epoche precedenti non avevano in esse ancora notato; solo per questa ragione un’opera fiabesca come Il flauto magico, ma anche un’epopea storicamente localizzata come l’Iliade, hanno una cosiddetta eterna giovinezza.
Ernst Bloch, Il principio speranza
Non solo un universale astratto,
ma un universale tale che abbracci in sé
tutta la ricchezza del particolare.
GeorgW. Friedrich Hegel, Scienza della logica
Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che ha molti indizi, mio malgrado, di venire.
La parola scritta m’ha insegnato ad ascoltare la voce umana, press’a poco come gli atteggiamenti maestosi e immoti delle statue m’hanno insegnato ad apprezzare i gesti degli uomini. Viceversa, con l’andar del tempo, la vita m’ha chiarito i libri [...]. Il vero luogo natio è quello dove per la prima volta si è posato uno sguardo consapevole su se stessi: la mia prima patria sono stati i libri.
Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano
Perché leggere i classici è meglio che non leggere i classici.
Italo Calvino, Perché leggere i classici
Nella nuova sistemazione della sede della prestigiosa Università Bocconi di Milano, nota in Italia e nel mondo per la formazione di economisti, di dirigenti d’azienda ecc., in linea con le esigenze del capitalismo e del mercato dominanti, in uno spiazzo antistante a un’entrata, era stata posta la scritta Knowledge That Matters, la conoscenza che conta. La conoscenza è intesa in questo caso come sapere scientifico, positivistico, addirittura limitato alla sola dinamica economica e gestionale (il famoso e celebrato management). Compariva a caratteri cubitali, a mo’ di monumento fatto di lettere staccate e alte, visibili a lunga distanza. Ora, questo è lo spirito del tempo. Lukács direbbe: “è la resa alla potenza del presente”.
Lo spirito che anima il libro che avete in mano invece è all’opposto. La conoscenza che a nostro avviso conta, che arricchisce gli esseri umani, è la conoscenza di come si sta al mondo, di come si concepisce l’essere umano, nella sfera individuale e nella sfera collettiva, nella società e nella storia. Certo, la cultura scientifica è importante, ma è soprattutto la cultura umanistica potenzialmente in grado di aiutarci a vivere e a orientarci in un mondo contemporaneo nel quale spesso ci si trova smarriti, disorientati. Malgrado le granitiche certezze, malgrado la presunzione, il senso apparente di padronanza e di sicumera.
Il sapere accumulato nei secoli, soprattutto con la vertiginosa accelerazione nei secoli di sviluppo del capitalismo, ha prodotto una sorta di prometeismo, di sicuro padroneggiamento del reale, da parte degli esseri umani, soprattutto nell’Occidente sviluppato, nei centri capitalistici avanzati. È lo “sviluppo delle capacità umane”, soprattutto per mezzo della scienza, della tecnica, dei mezzi di produzione, dalle macchine ai robot contemporanei. Altra cosa è lo “sviluppo della personalità”, lo sviluppo delle qualità umane, nei rapporti sociali e nella relazione con la natura e con l’ambiente circostante. È questo il retroterra da cui scaturisce la qualità della civiltà in ogni epoca e in ogni luogo del nostro pianeta.
Oggi esiste un’enorme produzione editoriale, di autobiografie, di romanzi, di gialli, accanto a una grande produzione di saggi su temi vari, e di vario valore. Ma molto spesso nel segno dell’esistenza effimera, del rapido dileguare consumistico, anche nella sfera culturale.
Oggi è il tempo nel quale al massimo il positivo viene qualificato “interessante”. Avere fermi convincimenti, affermare cose nette, dare definizioni generali ecc. non è giudicato “equilibrato”. È “divisivo”. Anche cercare di rispondere alla domanda “che cos’è la letteratura” è azzardato. È “totalizzante”, “ideologico”. È una generalizzazione pericolosa. Questo è.
L’accusa infamante di “ideologia”, in ogni momento e in ogni dove, è il marchio con cui si blocca ogni argomentazione, ogni discussione.
I.
“Leggere i classici è meglio che non leggere i classici”. Così argutamente Italo Calvino, come spesso egli usava, nel suo famoso articolo del 1986, dal titolo appunto Perché leggere i classici, concludendo le 14 ragioni per cui è bene leggere i classici. Esiste un canone, esiste una tradizione consolidata che stabilisce se un autore e un’opera siano da annoverare tra “i classici”. Si presume, come tradizione, che venga accettata dal maggior numero di persone.
Personalmente, parto dall’assunto che questo “canone occidentale” vada dai greci a Leonardo Sciascia, a Marguerite Yourcenar, a José Saramago. È una scelta di campo, è una scelta sicuramente soggettiva e pertanto opinabile. È discutibile. Certo, la sfida è sempre quella. Il poeta e pensatore romantico tedesco Friedrich Schiller, da par suo, ci ha dato la definizione più suggestiva della continuità negli accadimenti e nelle faccende umane, compresente alla ovvia discontinuità umana di epoche storiche, di culture, di condizioni economiche, sociali, politiche, di antropologie ecc. “E il sole di Omero, vedi, sorride anche a noi”. Il classico continua a sorridere a noi. Basta saperlo guardare e accogliere ancora oggi.
Tuttavia, accanto ai classici correntemente ritenuti dai più tali, esistono “i propri classici”. L’opera o le opere che hanno costituito un punto di svolta individuale nella propria vita, a misura dell’effetto prodotto, di piacere narrativo, di riflessione indotta e di profondo ripensamento del corso della propria esistenza, di rimessa in discussione individuale e nella vita associata nel processo di formazione della personale visione del mondo, della personale educazione sentimentale. I propri classici. Soprattutto nell’età di maggiore suscettibilità al cambiamento, emotivo, sentimentale, intellettuale. L’infanzia e la pubertà, sicuramente, ma poi soprattutto l’adolescenza e la giovinezza.
Gli esempi sono tanti. Gli anni dell’adolescenza sui banchi di scuola, le prime prove sentimentali e il primo formarsi di una concezione del mondo. Allora un romanzo come Un anno di scuola di Giani Stuparich diventa la lettura con forte scossa emotiva e intellettuale, diventa “un proprio classico”. Anche se questo romanzo dai più non viene considerato tale. Così come la lettura, appena appresa la capacità di leggere e scrivere, di Pinocchio di Carlo Collodi. Così come, solo come esempio di un profondo conoscitore della letteratura, avvenne al ragazzo Claudio Magris con la lettura del romanzo di Emilio Salgari I misteri della giungla nera.
Così come, nell’esperienza personale dello scrivente, la precoce lettura nelle medie inferiori di Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, di Le parrocchie di Regalpetra di Leonardo Sciascia e del libro I dannati della terra di Frantz Fanon, quale manifesto di quello che dopo si costituì come terzomondismo e come rovesciamento della prospettiva storica planetaria. La rivelazione che il mondo è irrimediabilmente scisso, diviso, ingiusto. E che il proprio mondo europeo e occidentale, ritenuto avanzato, civile, democratico, fronte della storia, in realtà è la parte del pianeta che ha oppresso, sfruttato, rapinato altri popoli, altre aree del mondo.
Pur nei limiti della lettura precoce e della limitata comprensione, normali a quell’età, tutto ciò produsse un profondo ripensamento delle proprie origini, della propria collocazione nella società, della necessaria ridefinizione della personale visione del mondo.
II.
Questo libro si propone il fine di costituire un avviamento alla lettura. Quale prima strumentazione, quale primo bagaglio per affrontare il viaggio all’affascinante scoperta del vasto continente letteratura. È la presente opera il risultato di vari processi e di varie dinamiche.
Da una parte, il sempre ovvio e necessario processo individuale. Ed è la soggettiva esperienza di vita personale e le riflessioni accumulate nel tempo, come avviene in tutti noi esseri umani, anche e soprattutto nell’esperienza personale di lettore. Di chi ha avuto la fortuna di poter studiare e di frequentare persone e ambienti sollecitanti cultura, riflessione, modi civili, solidarietà umana, amore per la cultura e per la politica nobile.
Dall’altra, il processo collettivo. Nella vita associata, dal contesto di origine e di appartenenza alle comunità in cui, nel corso del tempo, si viene a far parte, si è coinvolti. Tutto ciò si risolve in apporti, taluni fondamentali e decisivi, tratti dalla vita collettiva, nella società e nella storia, dalle influenze culturali, dalle formazioni, scolastiche e non, dalle contaminazioni, dalle letture fatte ecc.
Tuttavia, per quanto riguarda lo scrivente, importanti sono stati i 19 anni trascorsi come conduttore di un gruppo di lettura presso la Biblioteca comunale di Bollate (Milano) e gli anni, dal 2009 in avanti, come animatore dei cicli di letteratura “La letteratura come vita e come riflessione sulla vita. Il classico che è in noi”.
Alla luce di queste attività ed esperienze e alla luce, in senso largo, della propria formazione culturale, questo libro è inteso come una semplice guida alla lettura dei classici della letteratura.
Una guida e un breviario-compendio, tra i tanti esistenti.
Molti di questi pregevoli sicuramente, ma il presente scaturente dal profondo, modesto bisogno personale di comunicare ad altri e ad altre, di condividere il proprio sentimento profondo, proprio così, di gratitudine per questo lascito della storia umana rappresentato dalla letteratura. Nel poter disporre di questo tesoro, di questa immensa ricchezza a nostra disposizione. Gratuitamente, non privatizzabile. Un’eredità immensa. Un bene comune dell’umanità.
Il fine perseguito, pertanto, nel concepire e nel realizzare il libro, è quello di evitare i due estremi, i due poli opposti. Da un lato, lo specialismo, altrimenti questa guida non risulterebbe utile. Dall’altro, la banalizzazione, il dilettantismo o la “stravaganza” delle parole in libertà, delle affermazioni non fondate sulla conoscenza delle opere e della critica. Il tentativo perseguito è stato pertanto quello di poter conseguire un tertium datur tra i due estremi del saggio specialistico, da una parte, e della banale esposizione, piuttosto povera di contenuti, dall’altra.
III.
Questa introduzione è intesa a dare preliminarmente alcune indicazioni di metodo, sulla natura e sulla finalità di questa attività culturale. Scrivo “culturale” a ragion veduta. Dal momento che, nella visione di cui adesso svolgiamo alcune considerazioni, in cui esplicitiamo la nostra visione del mondo, non solo di letteratura si tratta. La letteratura è un viatico, costituisce un prezioso mezzo. È la via regia per conseguire l’affinamento del sentire, per alimentare i sentimenti, per costruire una cultura generale e una indispensabile visione complessiva del mondo. Del mondo esteriore e del mondo interiore.
In una realtà contemporanea dove “tutto si tiene”. Dove le culture e le subculture dominanti tendono a frammentare, a volatilizzare, a rendere effimera ed evanescente ogni esperienza di vita, ma che al contempo tendono a omologare e a omogeneizzare. Nell’apparente vita frammentata ed effimera, con la pretesa, proclamata fine delle ideologie e delle visioni complessive del mondo, i dominanti impongono il pensiero unico, l’ideologia dominante del mercato, del capitalismo come unico orizzonte invalicabile dell’umanità.
Nell’epoca del trionfo del frammento, del disincanto, del postmodernismo, della filosofia complessiva del neoliberismo, la letteratura, e i classici in primo luogo, invece costituiscono potenti stimoli ad avere una visione complessiva, a mettere in relazione, a creare ponti, nessi, interazioni tra le varie parti della realtà, materiale e spirituale. È propriamente questa la dinamica intrinseca di quella gran cosa che è la cultura. E la letteratura ne è parte integrante fondamentale.
IV.
La cultura è tante cose. È ciò che si eredita dal contesto familiare e dal contesto storico-sociale da cui si proviene (comportamenti, costumi, idee, concezioni del mondo, condotte di vita ecc.) ed è al contempo ciò che si costruisce nel corso della propria vita come coscienza, come consapevolezza, come acquisto.
Cultura è come si sta al mondo. Cultura è ciò che ci spinge a preparare, a desiderare nuove forme di vita. E ciò riguarda sia la semplice persona della vita quotidiana, sia il raffinato intellettuale, sia l’uomo e la donna collocati nei luoghi del potere.
I libri e la cultura non rappresentano il fine ultimo. Essi costituiscono piuttosto i mezzi per conseguire il fine ultimo. Il fine ultimo è sempre l’uomo, gli esseri umani, quanti più uomini e donne, viventi in carne e ossa, che lavorano, che soffrono o che gioiscono, che lottano. È quello che dice Antonio Gramsci al figlio Delio, a proposito della storia, nella famosa, per molti versi commovente, ultima lettera dal carcere, poco prima di morire nel 1937.
V.
“La letteratura come vita e come riflessione sulla vita. Il classico che è in noi”. Questo è il titolo complessivo degli incontri annuali tenuti tra il 2009 e il 2021 e nei quali ho cercato di compendiare la concezione personale di questa parte così decisiva dell’attività umana, dai primordi a oggi.
In questo risiede il grande valore e la peculiarità della letteratura. Quando è grande, essa mostra, rappresenta per immagini, per metafore, la vita così com’è. Anche in modo fantastico. Ma al contempo, in modo implicito o esplicito, nelle concezioni e nelle visioni del mondo del creatore-scrittore e dei personaggi rappresentati nell’opera, essa veicola idee, pensieri, culture, filosofie, spontanee e ingenue o sofisticate ed elevate.
Vita quotidiana, vita sociale e politica, storia, economia, filosofia, religione, sociologia, antropologia, psicologia, arte ecc. confluiscono nel fatto letterario e al contempo dall’opera scaturiscono a loro volta come stimoli, come impulsi nella considerazione e nella riflessione del fruitore-lettore dell’opera stessa.
I “classici” costituiscono il luogo privilegiato di questa concezione della letteratura. Passati attraverso il vaglio di generazioni umane, attraverso la verifica della storia e del tempo, sono depurati del contingente, dell’effimero e del caduco e giungono a rivestire i caratteri universali e universalizzabili di aspetti che rimangono.
Come dice Ernst Bloch, le grandi opere d’arte, e quindi i classici della letteratura, contengono una “eccedenza”, un “sovrappiù”, ma anche una “prefigurazione” che vanno oltre, che travalicano il contesto da cui sono nati. E tutto ciò giunge a noi, parla a noi, anche a distanza di secoli e di millenni, solo se si abbia disposizione interiore e animo ricettivi. Il classico ci scuote e ci costringe a metterci in gioco, a pensare, a riflettere, a mettere a confronto il mondo della nostra vita con il mondo dell’opera.
Il poeta inglese di metà Ottocento Robert Browning espresse in modo netto ed efficace tutto ciò. I go to prove my soul. Metto in gioco me stesso e la mia anima. Mi confronto, confronto il mio mondo col mondo rappresentato dall’opera, nel mentre leggo o nel mentre fruisco dell’opera d’arte. È la forza, è la potente carica contenuta nell’esperienza artistica in generale.
Mentre leggiamo, o mentre guardiamo un’opera delle arti figurative, ammiriamo la facciata di una cattedrale, ascoltiamo musica, sospendiamo per quel tempo la nostra quotidianità, fatta spesso anche di banalità e di vita inautentica. Come dicono i francesi, il faut reculer pour mieux sauter. È un fermarsi, anche indietreggiare, per saltare meglio, per continuare meglio la nostra vita. Per continuare meglio il lavoro, le nostre relazioni sociali e affettive, per essere cittadini e cittadine migliori nella nostra vita quotidiana, nella comunità e nel mondo in cui viviamo.
La lettura è un potente stimolo a pensare, a riflettere sulla propria vita e su quella degli altri, sulla vita della società e del mondo in cui si vive. Quello che magari in noi era ancora confuso, non completamente elaborato, soprattutto non reso esplicito nella nostra considerazione, l’autore e l’opera in alcuni passaggi narrativi ci offrono le parole giuste, le espressioni giuste, la riflessione giusta, la chiarezza per esprimere esplicitamente ciò che era implicito o, come dice sempre Ernst Bloch, rimaneva “non-ancora-conscio”.
VI.
L’essere umano è un campo di possibilità. Il retroterra da cui si parte, repetita iuvant, è la concezione, molto studiata e argomentata da György Lukács, secondo la quale in gioco non è solo, come si diceva prima, lo “sviluppo delle capacità umane”. Sviluppo che compendia l’evoluzione umana e la storia (evoluzione materiale, mezzi di produzione, scienza, tecnica, padronanza sulle forze della natura e sulla dinamica storica, sociale, politica ecc.) e che il capitalismo ha accelerato in modo impressionante. In gioco è piuttosto, sempre come si diceva prima, lo “sviluppo della personalità umana”, lo sviluppo delle qualità umane, quale realizzazione, sempre entro il contesto della società e della storia, dei caratteri di un’umanità disalienata, conformi al senso di integrità e di dignità umane.
Socrate e Gesù di Nazareth, come esempi classici, canonici, incarnano questa realizzazione. Individui-personalità pienamente sviluppati, in sé, ma anche e soprattutto come appartenenti alla comunità in cui crescono, agiscono, pensano, lottano, ecc. È il contesto, insopprimibile, avvolgente, di cui anche personalità di eccezionale livello morale e intellettuale non possono fare a meno.
VII.
Le note introduttive alle varie opere qui prese in esame si propongono di agevolare e di approfondire la lettura di libri di narrativa e di poesia, in primo luogo, ma anche saggi, senza presupporre nel lettore formazione specifica o specialistica. L’unico presupposto è il desiderio di conoscere e di attingere all’immensa ricchezza del patrimonio letterario dell’umanità. E di concepire la lettura non solo come piacere e divertimento, ma anche quale strumento fondamentale della formazione etica, culturale e politica della persona. Come si diceva un tempo, la lettura intesa quale strumento dell’elevamento culturale e civile, spirituale della persona.
“La via regia alla filosofia è il pensiero autonomo”. Così diceva Hegel in uno dei suoi splendidi Aforismi jenensi. Così è per la letteratura. La conoscenza diretta dell’opera è il requisito minimo. E le considerazioni e le riflessioni personali sono molto importanti.
Pensare autonomamente, ma senza “stravaganza”. Una buona guida, tuttavia, può aiutare a cogliere parte della ricchezza che l’opera possiede. Va da sé che la rilettura in momenti successivi aiuta. Un conto è leggere un grande classico a 14-16 anni e un conto è leggere lo stesso nella maturità o nella vecchiaia, in un’altra stagione della propria vita. Con altra disposizione di sentire e di intendimento, con altra maturazione.
Il diverso bagaglio culturale, la diversa disposizione d’animo, a misura delle esperienze e delle alterne vicende della vita, nel bene e nel male, nella gioia e nel dolore, la differente consapevolezza indurranno il lettore a nuove considerazioni e a nuove riflessioni. A cogliere aspetti in precedenza trascurati o non colti. A vivere più intensamente l’esperienza artistica.
La letteratura è qui considerata nella sua accezione più vasta. Nel corso degli anni nei cicli di incontri si sono lette e prese in considerazione anche opere filosofiche, storiche, saggistiche ecc. Nel libro compaiono quindi anche note introduttive a questi libri.
VIII.
Alcune premesse generali a proposito della letteratura e dell’arte in generale. Alcune sono anche considerazioni “filosofiche”.
L’essere sociale è l’essere di natura che diventa umano e che si costituisce in soggetto. E il soggetto si distacca dalla sola evoluzione naturale e pertanto sorgono con esso esplicitamente le tre grandi categorie fondamentali della condizione umana:
1. La storicità. Perché tutto è nella storia. Tutto è nello spazio e nel tempo. È il condizionamento storico ineludibile in ogni aspetto del reale, materiale e spirituale.
2. La socialità. Perché l’essere umano è animale gregario, è animale sociale (Aristotele). Alla nascita si viene a trovare in un gruppo umano più vasto. Come osserva Marx nei Grundrisse, solo attraverso la società eventualmente si isola, diventa individuo isolato.
3. La processualità. Perché tutto è in processo. L’essere in quanto essere non esiste. L’essere è il processo. Il qui e ora del reale è solo un fotogramma distaccato dal fluire della narrazione della vita. È una fotografia. Ma la vita, la società, la storia sono nel processo, nel divenire. Non sono fotogrammi isolati.
Genesi e struttura. Il processo genetico-evolutivo è la prima istanza da cui partire per comprendere, per conoscere. Porre il condizionamento storico, considerare il retroterra storico sempre e ovunque. L’esigenza è quella di comprendere i contesti sociali, economici, culturali, politici, antropologici ecc. per intendere profondamente i fenomeni culturali e quindi anche i fenomeni letterari.
Ma esiste la “corrispondenza biunivoca”, la strada a doppio senso. Il contesto e il retroterra storico determinano, influenzano, condizionano. Ma a loro volta i fenomeni culturali e letterari retroagiscono e determinano e condizionano l’evoluzione complessiva del singolo individuo e della società e della storia. Influenzano in alcuni casi anche decisamente l’evoluzione complessiva della vita associata.
Per comprendere appieno l’Iliade e l’Odissea si deve ricostruire il retroterra storico e culturale da cui promanavano la civiltà micenea, gli eroi dei due poemi, Omero o gli Omeri, l’oralità delle varie narrazioni prima e poi la codificazione nella scrittura con la comparsa dell’alfabeto greco a partire dal VIII secolo a. C. Ma poi capire anche che l’Iliade e l’Odissea a loro volta hanno plasmato la civiltà greca classica. Hanno costituito il “canone” per la paideia, per la formazione dei fanciulli e delle fanciulle, dei cittadini delle città-stato greche.
Per comprendere Balzac e i suoi romanzi, per intendere Illusioni perdute, Splendori e miserie delle cortigiane, Papà Goriot, Eugenie Grandet, Gobseck ecc. dovremmo aver chiaro che cos’è il capitalismo, cos’era la Francia della Restaurazione, cos’erano in quel particolare contesto i baroni della finanza, accanto o sovrapposti agli esponenti tradizionali dell’aristocrazia terriera.
Essi sono gli avventurieri, piccoli e grandi, dell’argent, del denaro. Il denaro a mo’ di despota, di dio assoluto, monoteismo perfetto, al cui cospetto le divinità religiose scompaiono. È, in questa realtà descritta da Balzac, il brulicare quotidiano di bottegai, mercanti, banchieri, usurai, faccendieri. Essi rappresentano i nuovi guerrieri dello spirito accumulativo. Il capitalismo insomma. In parallelo lo scorrere dello spirito competitivo, mercantile spesso, del giornalismo, dell’editoria, dell’arte, ecc.
Ma al contempo capire anche come la Comédie Humaine di Balzac abbia retroagito, per esempio, nell’influenzare Marx ed Engels nella comprensione della società capitalistica. E dia a noi oggi elementi importanti per intendere psicologie, antropologie, caratteri e tipi umani di questa società, dia a noi chiavi per comprendere la logica intrinseca del sistema capitalistico. In ultima analisi, per cogliere la vita in questa società.
Ricordiamo sempre che Marx pensò addirittura di scrivere un saggio su Balzac. Proposito poi non realizzato. E che Engels affermò, nella famosa lettera a Margaret Harkness nell’aprile 1888, che aveva imparato sulla società capitalistica più dai romanzi di Balzac che dalle opere di storici, di economisti, di statistici, ecc.
IX.
Qui di seguito alcune definizioni schematiche di letteratura. Soggettive sicuramente, a partire dalla propria visione, dalla propria personale predilezione. Va da sé che la verifica concreta di queste definizioni la si avrà nella lettura diretta delle opere, nel confronto diretto, concreto appunto, con le opere, con gli autori, con il contesto a cui alludono opere e autori.
“La prova del pudding consiste nel mangiarlo”. Si diceva e si dice nel mondo anglosassone. Alla fine, a nuotare si impara nuotando, a camminare camminando, a leggere leggendo. Si parte sempre e comunque dall’esperienza artistica, col contatto diretto con l’opera. Poi si affina la sensibilità artistica. Non c’è un prima e un dopo. L’arte stessa crea il senso estetico, crea il gusto, crea la sensibilità artistica (sempre Marx nella Introduzione ai Grundrisse).
1. La letteratura, quando è grande, coglie la vita nella sua totalità. Non solo come vita quotidiana, come svolgimento di vicende umane, ma anche come interazione delle altre sfere, delle tendenze storiche, culturali, politiche, filosofiche, religiose, antropologiche, psicologiche, ecc.
La letteratura ci consente di parlare sì della vita, di vicende umane, di sentimenti, di affetti, ma è anche il punto di avvio per trattare di storia, di economia, di sociologia, di filosofia, di scienza, di politica. È un potente stimolo a pensare, a riflettere, a elaborare. In ciò risiede il grande valore, la forza della letteratura.
2. La letteratura, come l’arte in generale, è la memoria dell’umanità, è l’autocoscienza dell’umanità. Sempre come sedimentazione di acquisti, di mete ecc. nella continuità del corso storico e sociale del genere umano. È, accanto al pensiero umanistico e al pensiero scientifico, l’accumulazione della ricchezza spirituale del genere umano.
3. La letteratura è un bene comune dell’umanità. Come l’acqua, i semi, la terra, la conoscenza, la salute, l’istruzione ecc. Un bene comune immenso, straordinario, a cui possiamo attingere liberamente. Non è appannaggio di un privato, non è privatizzabile. È potenzialmente a disposizione di tutti.
Ma l’esercitare l’eredità e il possesso di essa comporta che si affini la capacità di intenderla, di goderla. Questo libro è inteso anche a fornire alcuni strumenti utili per esercitare questa eredità.
4. Il libro, la letteratura, la conoscenza ecc. costituiscono anche forme di lotta. Rappresentano forme di resistenza contro l’ingiustizia, contro la manipolazione, contro la congiura e l’impostura del potere. Contro lo stato di minorità a cui si è tenuti da una società e da una storia ingiuste, improntate alla dialettica di dominio e di sottomissione, di potere e di mancanza di potere ecc. Il fine è sempre quello. Affinché tutti si possa essere in grado, come esseri umani, come appartenenti al genere umano, di fare come è detto nel Simposio di Platone. Ricercare il vero, operare il bene e il giusto, contemplare il bello. Al contempo. Come momenti correlati, non separati.
5. “La letteratura è verità”, in ultima istanza. Così dice Leonardo Sciascia in Nero su nero. Con la necessaria integrazione di Hegel nella Fenomenologia dello spirito. “Il vero è l’intero”. È il processo complessivo, è il respiro ampio della storia e dell’umano, la multilateralità, la multidimensionalità dei fenomeni umani.
6. La letteratura è vita concentrata, intensificata. Una sola esperienza di vita, la nostra, non basta. “La maturità è tutto”, dice Edgar nel Re Lear di Shakespeare. E allora occorre cumulare tante esperienze umane. Occorre imparare, dalla vita propria e da quella degli altri. La letteratura consente di fare ciò, di cumulare tante esperienze di vita.
Nella gioia e nel dolore. E spesso soprattutto si impara dal dolore. Eschilo, nel coro degli anziani nella tragedia Agamennone, nella trilogia dell’Orestea, dice appunto “conoscenza attraverso dolore”.
Il cumulo di tante esperienze umane, di caratteri, di tipi umani, di tanti contesti storici, sociali, culturali, antropologici, ecc. ci può consentire di maturare, di affinare sentimenti, affetti, idee, visioni del mondo. Ci può aiutare a ingentilirci. Nel generale contesto contemporaneo di abbrutimento individualistico, per molti versi consumistico, narcisistico, agonale, competitivo, aggressivo. La letteratura, così come l’arte in generale, possiede questo valore inestimabile.
Nel porci noi, nel misurare noi stessi e il nostro mondo, interiore ed esteriore, con i tipi umani, i caratteri, il mondo narrato o evocato dal racconto, dal romanzo, dall’opera d’arte, nel confrontare la nostra vita con la vita evocata e descritta dal racconto o dall’opera, allora alla fine della lettura o della contemplazione dell’opera d’arte noi non siamo più le persone di prima. Anche se impercettibilmente, noi siamo cambiati. Se poi il confronto è stato profondo, intenso, anche a misura del momento emozionale, morale o di maturazione personale nella coscienza del mondo, allora il cambiamento risulterà più forte, più significativo.
“I go to prove my soul”. Come ho ricordato poco sopra. Anche semplicemente mettendo a confronto se stesso, iniziando a leggere Guerra e pace, con Pierre Bezuchov, con Andrej Bolkonskij, con Natasa Rostova, con il contadino-soldato Platon Karataev, ecc. Anche semplicemente com’è nel momento di requie e di conciliazione con se stesso da parte di Fëdor Dostoevskij, sempre alle prese con i debiti, con il gioco, con l’essere il forzato della scrittura, con l’epilessia ecc. Requie e pace quando, seduto di fronte al quadro, per ore il grande scrittore russo contemplava la Madonna Sistina di Raffaello nella cattedrale di Dresda.
7. La catarsi era la categoria estetica che Aristotele usò per interpretare cosa avveniva nella comunità ateniese e attica nel corso del rito collettivo e religioso della rappresentazione della tragedia. L’esperienza collettiva e pubblica, il momento “politico” (della città, della polis, della comunità) così importante nella riproduzione complessiva della vita della comunità. La scossa emotiva e l’impulso a pensare, a riflettere per quegli uomini e per quelle donne. Così può avvenire in noi.
Katharsis, in greco, significa purgarsi, purificarsi dalle passioni cattive, dalle scorie di una vita inautentica, banale, non riflettuta. Anche se in misura impercettibile, anche se con piccole scosse emotive, il monito promana sempre dall’opera d’arte, dalla poesia, dal racconto, dalla statua, dal quadro, dalla musica ascoltata. Un monito ad aggiustare qualcosa della propria vita. Se non proprio, come può avvenire in alcune circostanze eccezionali, ma non così rare, come monito a cambiare vita.
8. La letteratura e la grande arte, da una parte, la coscienza storica, la filosofia, la scienza, la sociologia ecc., la vasta cultura umanistica e la vasta cultura scientifica, dall’altra, non operano rivoluzioni, non determinano cambiamenti storici e sociali. La cultura umanistica, l’arte e la letteratura, la cultura in ultima analisi, semplicemente possono, ripetiamo possono, indurre gli esseri umani a prepararsi a nuove forme di vita. A desiderare, a volere, a perseguire nuove forme di vita.
È la disposizione interiore a dover cambiare. Presupposto necessario per indurre l’agire, per procedere all’azione pratica, per la prassi sociale e politica. Agire e azione pratica dove occorre la famosa “razionalità conforme allo scopo”, la coerenza di fini e di mezzi, la capacità di mediazione, l’esatta cognizione dei reali rapporti di forza.
È la “corrente fredda” dell’analisi precisa del reale, nella grande metafora concepita dal filosofo marxista del Novecento Ernst Bloch. Nella quale metafora, la “corrente calda” esprime la volontà, l’impegno attivo, la soggettività, la disposizione interiore, la passione per la vita e per i cambiamenti di varia natura, anche rivoluzionari.
La compresenza e la giusta miscela-commistione di queste due correnti, nella vita quotidiana di uomini e donne e nella vita collettiva dei gruppi umani, è lo stato normale. Se prevale la corrente fredda si può cadere nell’opportunismo, nel fatalismo, nel quietismo, se prevale la corrente calda si può degenerare nell’ottimismo esaltato, nel soggettivismo, nel volontarismo, nell’avventurismo.
9. In breve, la mia personale concezione si configura come un’aperta, convinta apologia della letteratura, contestuale a un’aperta e convinta apologia della storia. In definitiva, in un’aperta e convinta apologia della cultura. Tutte premesse necessarie per una possibile “buona vita”, per una possibile “buona politica”.
La buona politica di gruppi dirigenti, del ceto politico, ma anche dei militanti. Un romanzo in più letto e la formazione politica e l’agire politico ne trarrebbero grande giovamento. Per la visione della politica come necessario esito delle due importanti premesse dell’etica e della cultura.
X.
Una breve digressione. Lo specialismo e lo sviluppo umano.
Dalle prime comunità neolitiche alla esasperata divisione e specializzazione del lavoro nel mondo contemporaneo. Costituendo la “rivoluzione neolitica”, l’avvio dell’agricoltura e dell’allevamento, e il contestuale avvio della “rivoluzione urbana”, la base della civiltà umana.
Con l’avvio della differenziazione sociale e di classe, ma anche dell’inizio della specializzazione nella forma della divisione del lavoro (fabbro, vasaio, tessitore, sacerdote ecc.), oltre a chi si dedica all’agricoltura e all’allevamento, le attività primarie per eccellenza. Questa divisione del lavoro, con in primo luogo la grande divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, da potente fattore di sviluppo della civiltà umana si è convertito e si converte in grave impedimento per un ulteriore salto di qualità dell’evoluzione umana.
Abbiamo a che fare così con l’essere umano unilaterale, unidimensionale, anche alienato. Il semplice e limitato operaio, i semplici e limitati impiegato, casalinga, medico, ingegnere, intellettuale, artista, sacerdote ecc. E ciò ha comportato e comporta tuttora l’atrofizzazione, il rattrappimento di altre possibili qualità umane. Soprattutto per i soggetti sociali subalterni, sfruttati, confinati al duro lavoro manuale, al duro lavoro ripetitivo, al duro lavoro casalingo (la questione femminile), ecc.
La letteratura, la grande arte, la cultura in generale, aiutano potentemente a contrastare questa tendenza. A porre, almeno anche solo a porre, il problema dello sviluppo onnilaterale della persona, il problema dell’allargamento del campo di possibilità umane.
Naturalmente sono poi le condizioni oggettive (economiche, sociali e politiche), i cambiamenti, le trasformazioni, che debbono sgomberare il campo dagli impedimenti per conseguire questa multilateralità. Un tempo si diceva la multilateralità dello “uomo intero” (ganzer Mensch), greco, rinascimentale e poi romantico. Ma molta umanità, i milioni e milioni di donne e uomini oggi nel pianeta, soprattutto nelle periferie del mondo, sono sempre alle prese con gli elementari problemi materiali di esistenza, sono alle prese con la triade decisiva dell’impedimento e dell’ostacolo allo sviluppo materiale e spirituale. La triade fondamentale, allora e oggi, formata da capitalismo-colonialismo/imperialismo-patriarcato.
Il compito pertanto rimane sempre quello. Pensiamo solo al grandioso processo storico della riduzione della giornata lavorativa, della riduzione del “tempo di lavoro” e di allargamento del “tempo libero”. Il tempo libero per lavoratrici e per lavoratori per uscire dalla condizione di abbrutimento e per guadagnare un potenziale sviluppo nell’istruzione, negli affetti, nei rapporti sociali. Tempo libero per organizzarsi sindacalmente e politicamente ecc.
Il capitalismo del Novecento è riuscito a occupare questo tempo libero per farne tempo di consumo e di divertissement, attraverso mass media, radio, televisione, pubblicità, industria culturale ecc. e oggi con la vasta rete dei social media. La pubblicità pervasiva e i modelli di vita e di consumo esibiti dai media hanno plasmato le menti. Con maggiore efficacia nel Nord Globale, a misura delle ricchezze e dei redditi qui disponibili, ma anche nel Sud Globale, come attrattiva sui modelli di vita e di consumo a cui aspirare, come miraggio, a misura della povertà e della non disponibilità di risorse in questa parte del pianeta.
Il nostro tempo, nel quale sono pervasive la “cultura del narcisismo” (Christopher Lasch), la “cultura del corpo” e la “cultura del consumo”, nel quale quella che nel lontano 1975 Pier Paolo Pasolini denunciava come “mutazione antropologica”, oggi si è definitivamente realizzata e consolidata, nel quale il virtuale e l’artificioso dei social network e della rete la fanno da padrone, ha bisogno di emanciparsi.
La lotta oggi si configura come lotta per l’emancipazione del lavoro, per chi il lavoro ce l’ha, anche se sempre più precario, e per chi invece non ce l’ha, e per l’emancipazione del tempo libero dal consumismo, dal narcisismo consumistico, dalla cultura del corpo, dalla cultura del divertissement. In breve, lotta e tendenza verso una società libera dalle molteplici forme dell’alienazione. In primo luogo, alienazione lavorativa e alienazione consumistica.
XI.
La letteratura, con i classici in particolare, presenta un’enorme galleria di tipi umani e di caratteri. Una miniera e una ricchezza umane che ci possono aiutare a maturare e a trovare la nostra strada per una vita che abbia un senso. Come misura e come confronto inevitabili rispetto alle nostre vite.
Qui di seguito alcuni esempi di questi tipi umani, di questi caratteri, solo come rapido riferimento alla ricchezza della letteratura universale. Molti si incontreranno nelle note introduttive alle singole opere letterarie.
Ettore “domatore di cavalli”, nell’Iliade, come valoroso combattente contro la tracotanza dell’invasore, come modello eterno del dovere da compiere, per se stesso e per la propria comunità di appartenenza, malgrado la probabile o sicura sconfitta a cui si va incontro. Come modello per coloro i quali, nella storia e nella vita, pensano che non sempre si sta con i vincitori. Definizione di sempre, dall’antichità a oggi, a opera del poeta latino Lucano, riferito a Catone l’Uticense, Victrix causa diis placuit sed victa Catoni (la causa vincente piacque agli dei, ma quella vinta piacque a Catone).
Antigone, come modello eterno della passione, della pazienza, della tenacia, della pietas, tipicamente femminili. Del fatto che ci sono leggi non scritte, non codificate, nella vita e nelle comunità che occorre osservare. E che esiste la religione della vita, in ogni tempo, accanto alla religione positiva del tempio, vigente nella propria comunità di appartenenza.
Odisseo-Ulisse, come modello eterno, nella storia dell’umanità, almeno di quella occidentale, del bisogno, sempre inappagato, di conoscere, di conoscere “le menti” di altri uomini. Come modello dell’uomo dal multiforme ingegno e dal coraggio dell’osare, del “calcolo” di contro all’immediato impulso barbarico della hybris, della tracotanza e della violenza, del non fermarsi, del non avere posa e requie.
Paolo e Francesca, nella Divina Commedia di Dante, come modelli eterni della semplicità, ma anche della tragicità del sentimento e dell’amore.
Don Chisciotte, come modello eterno di chi sbagliando anche, e rischiando il ridicolo, purtuttavia non si arrende all’evidente tramonto delle virtù cavalleresche in una incipiente società borghese e persegue queste virtù, persegue la sua Utopia, non si arrende all’evidenza del reale e cerca di andare oltre tale evidenza.
Eugène de Rastignac e Lucien Chardon (poi de Rubempré), personaggi balzachiani, come modelli eterni del giovane provinciale di belle speranze investito dalla hybris borghese-capitalistica dell’arricchimento, il primo, e della affermazione artistica, il secondo. Della scalata sociale a tutti i costi nella Parigi ottocentesca, città-mondo delle possibilità umane da conquistare, sfavillante e sordida a un tempo.
Julien Sorel, ne Il rosso e il nero, come anche Fabrizio Del Dongo ne La Certosa di Parma, in Stendhal, come caratteri-tipi umani del giovane ambizioso, energico e volitivo, soggiogato e spronato dal mito napoleonico, dirompente nella Francia, il primo, e nelle corti italiane del periodo della Restaurazione, il secondo.
Jean Valjean, il forte, infaticabile, retto personaggio ne I miserabili di Victor Hugo, quale testimonianza concreta della possibilità di conservare la forza dell’integrità umana e di osservare la religione della vita, al di là delle religioni positive, malgrado le durissime prove della vita, le continue ingiustizie, le persecuzioni, i travagli.
Anna Karenina e Madame Bovary, donne indimenticabili, che sbagliano, che cadono, che pagano di persona, ma che ricercano qualcosa di più elevato della loro banale esistenza quotidiana. E i loro creatori-autori, Lev N. Tolstoj e Gustave Flaubert, non possono che rimanere innamorati delle loro rispettive creature. Quale segno del rispetto della fragilità umana, e dell’essere equanimi nel giudicare, nella consapevolezza che l’essere umano è anche “compassionevole” e “misericordioso”.
Platon Karataev, il mužik-soldato, il contadino povero che vive all’unisono con la natura, natura egli stesso, e Pierre Bezuchov, il nobile che alla fine completa il suo romanzo di formazione proprio a contatto con l’autentico esponente del popolo russo, nella visione organicistica del Tolstoj di Guerra e pace.
Ivan Karamazov, quale negatore di Dio, ma in realtà “cercatore di Dio”, e Aljosa Karamazov quale scopritore della verità, della bellezza e della possibile salvezza dell’umanità nei fanciulli, negli innocenti.
Il principe Myskin, ne L’idiota di Dostoevskij, come incarnazione del Buono e del Bello, del Cristo contemporaneo.
Ivan Ilic Golovin, nel potente racconto, capolavoro di Tolstoj, La morte di Ivan Ilič, come l’esponente della oppressiva burocrazia zarista, in qualità di magistrato, che imposta la propria vita nel segno del comme il faut, come vita inautentica fondata sulle forme dell’apparenza, e al quale solo la malattia e poi l’agonia finale riescono a fargli intravedere la vita autentica a cui ha rinunciato nel corso della sua esistenza.
Hans Castorp, il giovane ingegnere borghese, nel grande romanzo di Thomas Mann La montagna incantata, ancora acerbo, ignaro della vita, ma che nei sette anni trascorsi nel microcosmo del sanatorio di Davos matura anche alla luce degli scontri dialettici dei tipi umani Lodovico Settembrini e Leo Naphta e grazie all’innamoramento di una donna e che ritorna al “piano” solo per concludere i suoi giorni nelle trincee e nell’ecatombe della prima guerra mondiale.
XII.
L’umanità si dispiega, dai primi ominidi a oggi, lungo una lunga linea evolutiva per cui la civiltà vera e propria (convenzionalmente dal 10.000 a. C., con l’avvio della cosiddetta “rivoluzione neolitica”, agricoltura e allevamento, e con la “rivoluzione urbana” che ne deriva) fino a oggi occupa solo un brevissimo tratto finale.
La gran parte delle generazioni di ominidi e delle generazioni umane ha vissuto in caverne, nelle condizioni precarissime di vita, nel condizionamento costante della natura di cui queste generazioni fanno parte e della quale sono semplice evoluzione. La caducità delle condizioni di vita, la necessità di non cadere vittima dei predatori e di reperire il cibo di cui alimentarsi, la presenza del pericolo del “combatti o fuggi”, delle malattie ecc. La civiltà è troppo recente e la sedimentazione antropologica della precarietà, della paura, dell’istinto, dell’immediatezza è molto oggettivata, esiste negli strati profondi della psiche. Si direbbe nell’anima umana.
Inoltre nell’evoluzione della civiltà hanno agito i condizionamenti storici, i condizionamenti economici, dei modi produzione, della organizzazione sociale, delle collocazioni sociali e di classe ecc. Allora comprendiamo come l’essere umano sia veramente un grande, ricco campo di possibilità. Humanus angelus e Humanus bestia, come polarizzazione nella vasta gamma di manifestazione dell’umano, diceva il filosofo Nicola Cusano.
Le unilaterali visioni di un Hobbes (“l’uomo lupo per l’altro uomo” ecc.) o di un Rousseau (la bontà originaria) sono appunto unilaterali, polarizzanti. Nel mezzo ci sta un enorme dispiegamento di tipi umani, di condizioni, di comportamenti, di possibilità umane. Inoltre la plasticità dell’umano. In quanto vero essere in divenire, un vero essere-in-processo, le infinite possibilità della trasformazione, testimoniano appunto questa malleabilità della specie umana.
La grande metafora, anche mitica, istantanea, della folgorazione, ma nella realtà storica un processo, un travaglio della trasformazione di Saul in Paolo di Tarso, dall’essere persecutore e repressore dei primi cristiani al divenire il grande, attivissimo, intelligente, organizzatore delle prime comunità cristiane, fondatore reale del movimento cristiano come chiesa-assemblea-comunità organizzata, rappresenta un sicuro modello, un riferimento preciso di questa dinamica.
La prima parte, dal titolo “L’alba dell’umanità”, del grande film di Stanley Kubrick 2001. Odissea nello spazio è potentemente suggestiva. Lo scimmione primordiale che si erge a Soggetto e agisce sull’Oggetto con in mano lo Strumento, il femore come arma di offesa, ma che poi diventa, nella impressionante parabola dello sviluppo umano, arnese-utensile-tecnologia (l’astronave) riassume in metafora grande la storia delle potenzialità umane. Costruttive, ma anche distruttive. È la dialettica irriducibile contenuta in questa evoluzione.
La letteratura e l’arte sono prodotti umani, al pari delle armi, della violenza, dell’oppressione, dello sfruttamento. Con lo sviluppo del pensiero, della filosofia, della religione, della scienza, della tecnologia e della armonia con la natura, esse ci indicano la strada “per apprestare il terreno alla gentilezza”, come dice Bertolt Brecht nella famosa poesia A coloro che verranno.
La strada per la possibile convivenza umana, nella società e nella storia, nel pianeta non più diviso tra potenti e senza potere, tra sfruttati e sfruttatori, tra supremazia bianca e umanità di non bianchi, di umiliati e offesi, tra Nord Globale e Sud Globale.
Non più nel delirio di onnipotenza dell’uomo che opprime altri uomini e donne e che opprime la natura.
Bibliografia minima generale
Qui di seguito si indicano solo alcune opere che si ritengono utili per un primo approccio, come primo avviamento alla letteratura e a che cos’è la letteratura. È a tutti gli effetti una “bibliografia minima”, per non appesantire il discorso. Realmente, come dice Goethe, “ogni inizio è difficile”. Ma proprio nell’inizio sta il segreto di un cammino veramente fecondo, lungimirante. Altri libri e altri strumenti occorrerebbe prendere in considerazione per ulteriori approfondimenti.
Alcuni libri consigliati non sono più in catalogo. Esiste tuttavia oggi un ampio commercio online di libri usati con il quale reperire queste opere.
In primo luogo si indicano due opere importanti come retroterra necessario da cui partire. Due opere che offrono il contesto entro cui inserire la storia della letteratura, i classici, i singoli autori e le singole opere. Sono i classici manuali scolastici delle scuole medie superiori di storia e della filosofia.
– Massimo Bontempelli – Ettore Bruni, Il senso della storia antica, Trevisini (i due volumi del biennio, storia dai primordi dell’umanità a Roma e storia di Roma fino alla caduta dell’Impero e ai primi regni romano-barbarici).
– Massimo Bontempelli – Ettore Bruni, Storia e coscienza storica, Trevisini (i tre volumi del triennio, storia medievale, storia moderna e storia contemporanea).
– Ernesto Balducci, Storia del pensiero umano, Cremonese (i tre volumi della storia della filosofia, ma nella giusta concezione di padre Ernesto Balducci “storia del pensiero umano”, non solo della filosofia occidentale. Pertanto molto spazio è dedicato alle filosofie, alle culture, alle religioni orientali, cinese, indiana, arabo-persiano-islamica ecc.).
Inoltre preziosa è l’opera complessiva di letteratura, non solo della letteratura italiana, entro una trattazione più ampia, prendendo in considerazione altre discipline delle scienze umane.
– A cura di Remo Ceserani e Lidia De Federicis, Il materiale e l’immaginario, Loescher (possibilmente nell’edizione originaria, l’edizione “grigia”, in 10 volumi). Ma vanno bene anche le versioni ridotte dell’opera, l’edizione “rossa” e l’edizione “blu”.
– György Lukács, Estetica, Einaudi (in due tomi, fuori catalogo). Opera ampia, complessa, di taglio filosofico appunto, ma fondamentale, per inquadrare lo specifico dell’estetico, e quindi dell’arte e della letteratura, entro una visione del mondo, entro una filosofia complessiva. Si veda l’introduzione a questo libro nella parte finale della presente opera dedicata al pensiero critico.
– György Lukács, Il marxismo e la critica letteraria, Einaudi (fuori catalogo). Alcuni saggi illuminanti, come confronto concreto con la letteratura, con alcuni autori, con alcune opere. Questi saggi prospettano una metodologia della critica letteraria e rendono concreto il godimento estetico delle opere letterarie.
– György Lukács, Saggi sul realismo, Einaudi (fuori catalogo).
– Autori Vari, La cultura del romanzo (a cura di Franco Moretti), Einaudi. Cinque volumi, in particolare nel primo volume, dal titolo La cultura del romanzo, i due saggi che aprono e chiudono il volume. Sono Mario Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo? e Claudio Magris, È pensabile il romanzo senza il mondo moderno?
– Franco Moretti, Il romanzo di formazione, Einaudi. Nella prima edizione pubblicato nel 1986 presso Garzanti.
– Antonio Gramsci, le note contenute nei Quaderni del carcere raccolte poi nel volume monografico Letteratura e vita nazionale, edizioni Einaudi o Editori Riuniti. Nondimeno la lettura degli interi Quaderni del carcere è consigliata poiché molti altri sono i luoghi dove Gramsci affronta problemi che attengono alla letteratura, agli autori e alle opere letterarie, con riferimenti frequenti ai contesti storici, culturali e politici.
– Erich Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi.
– Claudio Magris, Alfabeti, Garzanti.
– Le voci “classico”, “estetica”, “realismo” ecc. contenute nell’Enciclopedia Einaudi.
Infine un libro quale esempio di come la letteratura possa influenzare e consolidare la cultura generale, la conoscenza di altri ambiti del sapere e di contribuire ad alimentare gli ambiti fondamentali dell’attività umana quali l’etica e la politica.
– Siegbert Salomon Prawer, La biblioteca di Marx, Garzanti. Oggi ristampato, a cura di Donatello Santarone, presso Bordeaux con il titolo Marx e la letteratura mondiale.
Nota al testo
Il libro contiene note introduttive su alcune opere e su alcuni autori. Sono note redatte a suo tempo come preparazione agli incontri di letteratura nei vari cicli annuali svolti, riviste e modificate per la pubblicazione nella presente opera.
Sono schede introduttive con la funzione di avviamento alla lettura, contenenti informazioni, chiavi interpretative, considerazioni critiche, suggerimenti di temi e di contenuti rilevanti dell’opera presa in esame. A misura della predilezione e del gusto soggettivo personali, a misura dell’importanza accordata e pertanto alcune sono risultate brevi e altre un po’ più ampie.
In tutti i casi sono da considerarsi veramente “introduttive”. Non hanno la benché minima pretesa di essere esaustive, di avere carattere analitico approfondito. Pertanto è questo un libro anche di consultazione. Non è necessario leggerlo da cima a fondo. Si può leggere la singola nota introduttiva all’autore e all’opera che interessano, opera che eventualmente si ha intenzione di affrontare o si è appena finito di leggere.
A partire da questa constatazione, in alcune note si possono riscontrare anche ripetizioni, varie considerazioni che ricorrono, proprio perché conformi al contesto della nota, dell’opera e dell’autore. Un esempio è il richiamo ripetuto in varie note delle culture e delle subculture nel mondo contemporaneo fondate su “la cultura dell'io, la cultura del corpo, la cultura del narcisismo”. Assieme alla “cultura del virtuale”, all'uso smodato dei social e delle relazioni virtuali, al posto delle vere relazioni umane concrete. Questo contesto è poco riflettuto da forze politiche e sociali alternative. Da qui la ripetizione.
Nello spirito della finalità della presente opera, conforme allo spirito della finalità degli incontri di letteratura, non ci si è sottratti dal fare considerazioni di carattere generale, anche politico, di fare riferimenti all’oggi, ai problemi contemporanei. È sempre importante dichiarare questo. La letteratura, ripetiamo, è sì piacere, intrattenimento, abbandono al piacere della narrazione.
Nella concezione espressa nell’introduzione, la letteratura viene considerata anche e soprattutto come uno dei momenti importanti della formazione culturale in generale, ma soprattutto una parte importante del bagaglio di un qualunque soggetto che abbia responsabilità nella vita collettiva. Non solo quindi confinato nella sola sfera individuale.
Ogni bibliografia posta al termine della nota introduttiva è veramente minima. Si indicano solo libri ritenuti essenziali per chi avesse voglia di approfondire, di allargare l’orizzonte, di rendere la lettura stessa un’esperienza più intensa, più ricca. Spesso si troveranno indicazioni di libri esauriti, non più in circolazione. Oggi esiste un ampio commercio online di libri, usati e non, e qui si possono reperire. Esistono sempre le biblioteche pubbliche dove poter consultare e prendere a prestito.
Diciamo subito che siamo nel solco di un “canone occidentale”, entro la generale visione del cosiddetto “eurocentrismo”. Anche se Grecia e poi Russia appartengono a una visione più ampia, non propriamente eurocentrica. La Grecia come saldatura-ponte tra Oriente (civiltà monumentali del Vicino Oriente e civiltà rivierasche del Mediterraneo orientale) ed Egitto ecc. e Occidente vero e proprio. La Russia in seguito come saldatura-ponte tra Asia ed Europa. E da qui anche il valore, la potente carica di civiltà di realtà storiche e sociali che assolvono il compito della connessione, della messa in relazione di culture e di civiltà.
Le civiltà extraeuropee, le altre culture umane planetarie hanno sviluppato una grande arte e una grande letteratura. Dalle quali l’uomo e la donna occidentali possono trarre grande ispirazione, grande giovamento culturale.
La civiltà planetaria rimane sempre l’orizzonte. Il “pensiero planetario” del compianto padre Ernesto Balducci rimane il monito permanente per un futuro possibile del nostro mondo contemporaneo, così minacciato da pericolosi squilibri geopolitici, sociali, culturali e politici, da gravi problemi ambientali e climatici.
Per quanto riguarda la bibliografia minima posta sempre in calce alla nota introduttiva. Il retroterra storico e il contesto generale di ogni fenomeno culturale sono considerati sempre fondamentali. Come si può vedere, normalmente si indicano parti e capitoli corrispondenti al contesto storico dell’autore e dell’opera nel manuale di storia per i licei di qualche decennio fa Bontempelli-Bruni, Il senso della storia antica, Trevisini editore (in due volumi, dai primordi alla fine del mondo antico, per il biennio) e Bontempelli-Bruni, Storia e coscienza storica, Trevisini editore (in tre volumi, dal Medioevo alla società contemporanea, per il triennio). Per chiarezza espositiva e per ampiezza nei contenuti, negli approfondimenti. Manuali a pieno titolo capaci di soddisfare anche l’esigenza dei normali corsi universitari.
Naturalmente vanno bene anche i classici manuali scolastici. Per i licei e per le varie scuole medie superiori (il Villari, il Camera-Fabietti, ecc., come vengono correntemente denominati dagli studenti e dagli insegnanti). A misura del manuale che ognuno/ognuna ha magari a disposizione in casa, retaggio dei propri anni di studio o presenti perché in mano a studenti.
A cura di Remo Ceserani e Lidia De Federicis, Il materiale e l’immaginario, Loescher (possibilmente nell’edizione originaria, l’edizione “grigia”, in 10 volumi). È un’opera di grande valore culturale in senso lato. Al di là della sua destinazione scolastica. Non solo la letteratura è presa in considerazione. Costituisce un serio tentativo di mettere in relazione le varie dimensioni, di far agire la multilateralità della cultura umana sempre in relazione al retroterra storico, economico, sociale, ecc.
Alcune letterature e alcuni autori hanno nel presente libro maggiore spazio, sempre a misura della personale esperienza nei cicli di incontri di letteratura e della personale predilezione. Come si può vedere nel caso di Balzac, di Dostoevskij, di Tolstoj, di Mann, di Shakespeare, ecc. E poi di Leonardo Sciascia, di don Lorenzo Milani, di Platone, di Marx, di Lukács, di Bloch, di Gramsci, ecc.
È facile rilevare che mancano autori e opere di grande valore, insigni autori e grandi opere. Solo qualche esempio. Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, I miserabili di Victor Hugo, Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. E poi Ulisse di James Joyce, Il processo di Franz Kafka, L’uomo senza qualità di Robert Musil, ecc.
Il proposito, a suo tempo espresso nelle circostanze degli incontri di letteratura, era che, nel procedere dell’attività, prima o poi si sarebbero affrontate alcune di queste opere. Così come si sarebbero lette alcune opere di altre culture. Nelle ricche tradizioni del mondo arabo-persiano-islamico, dell’India, della Cina, del Giappone ecc. Come sempre, tuttavia, “l’arte è lunga e la vita è breve”.
L’assunto iniziale è che almeno questo lavoro possa risultare come stimolo e come motivazione per l’autonomo, di chi legge, viaggio intorno al mondo sconfinato della letteratura.
Segnalo che nella parte dedicata a William Shakespeare la nota introduttiva al Sogno di una notte di mezza estate è a cura di Laura Cantelmo. Amica insegnante a suo tempo di lingua e letteratura inglese e poetessa riconosciuta e apprezzata. Con Laura abbiamo collaborato negli incontri dei cicli di letteratura dedicati a Shakespeare ed è l’occasione per ringraziarla ancora una volta per questo.
Un vivo ringraziamento qui per Stefano Nutini e per Daniela Strona. Per il prezioso aiuto nella rilettura del testo con relative correzioni e relativi suggerimenti stilistici e di contenuto.
|