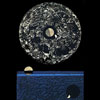|
|
Introduzione
Non sono molti i filosofi italiani contemporanei ai quali si possa riconoscere una apertura interculturale pari a quella di Aldo Capitini. Consapevole che la pace non è possibile senza un dialogo ed una intesa culturale tra i popoli, il padre della nonviolenza italiana negli anni della Guerra Fredda ha lavorato in particolare per il dialogo tra l’Oriente comunista e l’Occidente capitalista e liberale. La sua stessa proposta nonviolenta è il risultato di una apertura interculturale: la vita, il pensiero, la sfida nonviolenta di Gandhi, risultato della millenaria tradizione indiana dell’ahimsa ripensata alla luce di una certa tradizione radicale occidentale e russa (Ruskin e Tolstoj) si inseriscono in un lavoro del pensiero e in un travaglio esistenziale che gli avevano mostrato l’insufficienza, anche morale, tanto della tradizione religiosa cristiana e cattolica quanto dell’imperante filosofia neoidealista.
Nonostante questa notevole apertura teorica, non si può dire che Capitini sia riuscito a dare una dimensione internazionale alla sua ricerca. A differenza di Danilo Dolci, che ha viaggiato moltissimo ed ha stretto relazioni intellettuali con alcuni tra i maggiori educatori, attivisti sociali e filosofi del suo tempo, Capitini è rimasto confinato in una dimensione quasi provinciale che appare in singolare contrasto con l’apertura globale del suo pensiero. I confronti, che non mancano nei suoi libri, sono per lo più con autori italiani: Croce e Gentile nei primi scritti, Guido Calogero, De Martino ed altri negli anni successivi.
In questi ultimi anni gli studi capitiniani hanno fatto progressi significativi non solo grazie all’apporto di nuovi studiosi e alla continua dedizione di altri, come Mario Martini, curatore della fondamentale raccolta degli Scritti filosofici e religiosi, ma anche con la pubblicazione, a cura della Fondazione Aldo Capitini, degli epistolari del filosofo, una iniziativa che consente una conoscenza molto più approfondita dei suoi rapporti con il mondo intellettuale italiano, dei movimenti del suo pensiero, dei retroscena della sua prassi politica.
Se si sta cominciando a riconoscere in Capitini uno dei pensatori più originali del Novecento italiano, resta tuttavia quasi del tutto sconosciuto all’estero, anche per la mancanza di traduzioni nelle principali lingue europee.
La violenza è il problema di Capitini. Il punto d’origine del suo pensiero, la domanda che attraversa tutte le sue pagine, la spina che muove la sua azione politica. È la violenza di un io su un tu, di un popolo su un popolo nemico, dell’oppressore sull’oppresso. Ma è, anche, la violenza del tempo che ci consuma giorno dopo giorno, l’assurdo del diventare cosa, il dolore atroce di assistere al diventare cosa dell’altro che amiamo. C’è un’offesa che accompagna ogni nostro istante, un nihilum che ci stringe in una morsa dolorosa. Denunciare l’offesa è il primo atto di Capitini. Una decisione, prima ancora che un’idea: la decisione di non accettare la morte dell’altro. Non la propria: se la mia morte è un dramma, la morte dell’altro è un assurdo che assedia il fondamento stesso della mia vita morale. Perché nel rapporto etico con l’altro – e questo è l’altro polo, quello positivo, oserei dire classico, del suo pensiero – io avverto il suo valore assoluto, la sua inviolabilità, l’impossibilità di esercitare violenza su di lui. Che ne è di questo assoluto, se c’è la morte? E tuttavia come pensare oltre la morte pur restando nel disincanto, abitando con consapevolezza l’epoca della morte di Dio? È l’impresa difficile, coraggiosa e suggestiva di Capitini, che approda alla compresenza, una audace costruzione intellettuale e al tempo stesso una impegnativa proposta pratica che nel contesto della filosofia italiana appare quasi come un oggetto fuori luogo, che non si sa dove collocare, come interpretare, e si finisce per abbandonare a sé stesso.
La filosofia di Capitini passa dal sostantivo all’avverbio, dalla sostanza al modo: dall’infinito all’infinitamente, dall’assoluto all’assolutamente. Dio non è l’Ente creatore del mondo, gli assoluti sono tramontati. Ma qui ed ora, faccia a faccia con il tu, è possibile amare infinitamente, assolutamente. Non è una filosofia per l’uomo e la donna presi nella loro medietà heideggeriana. La nostra quotidianità relazionale è fatta di ostilità, incomprensioni, rancori, competizione, fastidio. Ma è possibile l’amore. Può accadere. Il tu può essere accanto, insieme, invece che contro. Si può vivere nella sospensione della lotta, si può praticare, pur tra mille ostacoli e cedimenti, il sentiero della pace. Questa possibilità relazionale, questa pratica possibile, apre, fonda, giustifica una nuova ermeneutica; l’essere, considerato nella luce di questa apertura, si mostra aperto esso stesso, libero dai vincoli della necessità, dagli impedimenti della violenza, dalla morsa della morte. Questo essere-possibile, aperto qui ed ora nell’apertura al tu, è la compresenza.
Nel primo capitolo ne tento una lettura alla luce di una tradizione di pensiero con la quale è urgente un confronto filosofico in Occidente: quella del buddhismo, e segnatamente dello zen, rappresentato da Nishitani Keiji, uno dei più importanti pensatori giapponesi del Novecento. Al centro della sua filosofia, che molto deve al confronto con il pensiero occidentale (in particolare con quello di Martin Heidegger), c’è un profondo ripensamento della vacuità buddhista. La vacuità è altro da qualsiasi categoria metafisica occidentale, ed è singolare che i pensatori europei contemporanei, così impegnati a denunciare il carattere violento della metafisica occidentale, abbiamo mostrato così poco interesse per la tradizione buddhista, dalla Prajñāpāramitā e Nāgārjuna fino allo zen ed alla scuola di Kyoto (ma lo stesso si può dire per il pensiero cinese). La lettura parallela di Capitini e Nishitani mostra, oltre alle innegabili (e inevitabili) diversità, alcuni singolari punti di convergenza, riguardanti la relazione io-tu e l’etica, la temporalità, l’apertura al possibile. Temi che conducono alla questione centrale del saggio: quale spiritualità dopo il tramondo delle religioni e la morte di Dio?
Nel secondo capitolo Capitini dialoga con un pensatore che è a lui particolarmente affine, soprattutto per la centralità del tema della liberazione. Tra i più importanti rappresentanti della filosofia latino-americana, Enrique Dussel denuncia il carattere violento della tradizione metafisica europea contro la quale leva la voce dell’oppresso che esige l’atto rivoluzionario. Sul ruolo della violenza in questo processo di liberazione Capitini e i Dussel (che ignora, per quello che ne so, Capitini, mentre ha dialogato, anche scontrandosi, con Gianni Vattimo) hanno posizioni diverse; nella mia lettura, il radicale rifiuto della violenza da parte del filosofo italiano comporta anche, benché possa sembrare il contrario, una maggiore radicalità rivoluzionaria.
Il tema della rivoluzione è anche al centro del terzo dialogo, quello con Murray Bookchin, uno dei più significativi pensatori anarchici della seconda metà del Novecento. La proposta del potere di tutti ha fatto sì che la figura di Capitini suscitasse non poco interesse presso gli anarchici italiani, nonostante qualche perplessità dovuta alla terminologia religiosa. Ed è il potere al centro del terzo capitolo. Come Capitini, il filosofo newyorkese cerca un potere dal basso, distribuito, che abbia il suo centro non nello Stato, ma nel comune. Avendo sviluppato il suo pensiero negli anni in cui si è imposto il problema della crisi ecologica, che è ancora oggi il più urgente, si è interrogato anche sui rapporti tra potere e devastazione ambientale, considerando l’organizzazione anarchica della società come unica praticabile via d’uscita da un capitalismo aggressivo che rischia di rendere semplicemente impossibile la vita sul pianeta, oltre ad essere fonte di oppressioni e ingiustizie. Il potere, oltre a strutturare gerarchicamente la realtà, opera per esclusioni, come un cerchio che sempre torna a chiudersi; per questo ripensare profondamente, radicalmente il potere richiede, dal punto di vista di Capitini (e questa è quella che potremmo chiamare l’aggiunta capitiniana al municipalismo libertario), un rifiuto e una protesta contro quella che considera la prima di tutte le esclusioni, la separazione che fonda la violenza occidentale: quella tra morti e viventi.
Questo libro esce a vent’anni esatti dal mio primo studio su Capitini. In questi vent’anni, il suo pensiero non ha smesso per me di essere fonte di ispirazione, stimolo, provocazione, indirizzo, e in qualche caso anche di consolazione. Il mio auspicio è che qualcosa di questa ricchezza (spirituale, filosofica, politica: umana) possa giungere al lettore attraverso queste pagine; e spero che gli giungano anche la potenza della riflessione esistenziale di Nishitani, lo slancio verso la liberazione di Dussel, il rigore politico di Bookchin.
Antonio Vigilante
Siena, dicembre 2018
Il primo capitolo è comparso in Aa. Vv., Il pensiero e le opere di Aldo Capitini nella coscienza delle nuove generazioni, Atti della I Giornata dei giovani studiosi capitiniani (Perugia, 14 marzo 2009), a cura di G. Moscati, Levante, Bari 2010; il secondo è stato pubblicato in Educazione Democratica, n. 8, giugno 2014; il terzo in Educazione Aperta, numero 4, estate 2018. Poiché i singoli saggi sono stati pubblicati separatamente, è inevitabile che vi sia qualche ripetizione, anche se uno stesso tema risalta in modo diverso nel contesto dialogico.
|