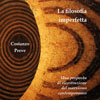|
|
Introduzione
Un apparente paradosso storico sta al centro del nostro presente filosofico. «Il grande problema dell’epoca (come scrive Lukàcs e correttamente rileva il traduttore italiano della sua autobiografia Pensiero Vissuto, Alberto Scarponi) è l’individualità». Il problema dell’individualità, cioè della particolarizzazione delle singole personalità umano-sociali, non è un problema genericamente metafisico o trascendentalistico, ma è un problema integralmente storico, ed anzi storicamente del tutto determinato, in quanto è strettamente connesso con la creazione per l’individuo di condizioni di vita astrattamente casuali, insorte con il declino delle società organiche, castali e divise in ceti e con l’emergere dei rapporti sociali capitalistici nel loro progressivo e contraddittorio tentativo di manipolare e colonizzare sempre più la vita quotidiana.
Il paradosso di una individualità umano-sociale che non può più determinarsi sulla base “sostantiva” dell’appartenenza a ceti (o a “classi” concepite come soggetti universali sostantivi, del tipo di una classe operaia sostantivizzata e resa gigantesca ed eterna), ma deve vivere fino in fondo la propria casualità senza per questo scivolare nel disperato sradicamento dell’intellettuale cosmopolita (per i più colti o acculturati) o nel nichilismo autodistruttivo del conformismo non-conformistico di massa (per i più fragili ed indifesi), è a tutti gli effetti un paradosso dell’oggi.
Come dice molto bene Lukàcs, «il divenire dell’uomo in quanto uomo è, come processo complessivo, la medesima cosa del costituirsi dell’essere sociale in quanto specie d’essere peculiare. Nell’iniziale stato gregario l’uomo singolo quasi non si distingue dalla mera singolarità, che è presente ed operante in ogni punto della natura inorganica ed organica. Ma il salto che – sebbene in un lungo periodo di tempo – lo trasforma da ente naturale ad ente sociale, fin dall’inizio si impone con intensità ed estensione sempre maggiori» (cfr. G. Lukàcs, Ontologia dell’essere sociale, Editori Riuniti, voll. 3, Roma 1976-1981, 2, p. 570).
Il passaggio dalla singolarità alla particolarità individuale è dunque un passaggio ontologicamente connesso (per l’essere umano sociale) con la generalizzazione di rapporti sociali in cui l’astrazione del lavoro e la casualità della collocazione sociale sono ormai elementi strutturali.
La forma della particolarità individuale è dunque filosoficamente “tipica” della generalizzazione e dell’approfondimento del modo di produzione capitalistico almeno quanto lo è la forma del “lavoro” (capitalistico diviso). Certo, la presenza dell’individuo (l’individuo, ricordiamolo ancora una volta, nella sua astrattezza determinata dalla sua strutturale casualità, non l’individuo posto in modo trascendentale come origine delle scelte sociali alternative, cui non crediamo per nulla) è coessenziale alla struttura fondamentale dei processi sociali. Questi ultimi, come afferma Lukàcs (cfr. Ontologia dell’essere sociale, cit., I, p. 337) «muovono immediatamente da posizioni teleologiche, determinate in senso alternativo, di singoli uomini, tuttavia, dato il decorso causale delle posizioni teleologiche, queste sfociano in un processo causale contraddittoriamente unitario dei complessi sociali e della loro totalità e producono connessioni legali generali», che di nuovo pongono problemi su cui si esercitano ancora una volta le decisioni alternative dei singoli.
In generale, tuttavia, l’individuo tardo-capitalistico che cerca di auto-comprendere la propria tipicità, singolarità, e particolarità, rilutta apertamente di fronte alla prospettiva teorico-pratica di una considerazione ontologico-sociale di questa particolarità stessa. L’auto-comprensione esistenzialistica della particolarità individuale evita in generale di considerare l’esserci (cioè, l’essere esistenziale nel mondo) sotto l’aspetto della strutturalità e della determinatezza dell’esserci-così capitalistico. La soggettività è sempre più personalizzata, quanto più l’individualizzazione è legata alla casualità della collocazione sociale ed all’impersonalità necessaria delle strutture riproduttive sociali. Il “capitale” non è né una sorta di antropomorfico soggetto onnipotente e tutto-pianificante né un insieme di imprenditori innovatori e/o di tagliatori di cedole, così la “classe operaia” non è né un mega-soggetto dai muscoli ipertrofici e dalla memoria di elefante né un insieme di operai dai colletti bianchi e blù che votano in una assemblea sindacale.
È inevitabile, tuttavia, che la determinatezza ontologica dell’individualità venga spesso pensata, falsamente ma comprensibilmente, sotto il dominio della categoria di soggetto. Si tratta, in alcuni casi, di un puro e semplice errore di prospettiva, un “errore disinteressato”, ampiamente correggibile. In altri casi, invece, si tratta di una “deformazione interessata” per scopi di manipolazione ideologica, assolutamente incorreggibile. In questo caso, la reazione, ontologicamente inevitabile, dell’individualità particolare offesa, assume l’aspetto necessario dell’individualismo globalmente anti-marxista ed anti-comunista, antitetico-polare al soggettivismo olistico-sociale.
L’individualità conosce infatti soltanto “posizioni teleologiche”, mentre la categoria di soggetto, quando è pensata come terminale, iniziale e finale, di una totalità espressiva, è titolare di un’essenza che pretende contenere in sé, in modo immanente, una teleologia necessaria. Questa presunta teleologia è ovviamente il supporto teorico di una concezione del comunismo come utopia sintetica, in cui pubblico e privato, individuale e collettivo si fonderanno insieme, “soluzione definitiva dell’enigma della storia”.
Un’analisi disincantata della storia del marxismo ci permette di comprendere come il materialismo storico e la critica dell’economia politica siano stati entrambi incorporati in una forma filosofica del discorso del tipo che sopra si è brevemente descritto. Ambizione di questo scritto è portare un piccolo contributo all’eliminazione di questa sciagurata camicia di forza.
Il materialismo storico, come il prigioniero rinserrato in una tremenda camicia di forza dai suoi carcerieri, di cui parla Jack London nel romanzo Il vagabondo delle stelle, non ha smesso e non smetterà comunque di sognare nuovi mondi, vie di uscita, evasioni impossibili. È tuttavia profonda convinzione dello scrivente che il materialismo storico finirà con l’essere sfiancato e soffocato da questa camicia di forza, finché l’odiosità di quest’ultima provocherà una reazione di rigetto tale da far preferire apertamente anche le visioni del mondo più assurde, irrazionalistiche e regressive, purché apparentemente non compromesse con la metafisica immanentistica di un Soggetto che marcia cantando verso l’Utopia Sintetica di una Società integralmente Trasparente.
Crediamo che una proposta sostitutiva di questa camicia di forza filosofica già esista, anche se non ancora ben sviluppata ed articolata, e sia appunto un discorso teorico di tipo ontologico-sociale, in grado di accompagnare la crescita di conoscenza e la correttezza dell’azione pratica che possono avvenire sulla base del materialismo storico. Vi sono però in proposito delle difficoltà, e ci limiteremo qui a menzionarne alcune.
In primo luogo, come è del resto del tutto evidente, non basta che una determinata forma filosofica del discorso (in questo caso di tipo ontologico-sociale) venga “proposta”, e variamente argomentata. Bisogna anche che essa venga realmente presa in considerazione, ed accettata entro un lasso di tempo non troppo lungo. Ora, le possibilità concrete che la forma filosofica del discorso di tipo ontologico-sociale “passi” in gruppi consistenti di “marxisti” italiani sono per ora molto poche. Da un lato, la frammentazione produttiva e sociale che risulta dall’attuale fase di sottomissione reale del lavoro al capitale produce “spontaneamente” una speculare “frammentazione filosofica”, nei discorsi post-moderni della perdita del centro, della caduta della dialettica, dell’ineffabile mistica del frammento, esattamente il contrario, cioè, del punto di vista ontologico-sociale.
Dall’altro lato, infine, il discorso filosofico di tipo ontologico-sociale è strettamente connesso, nel suo aspetto di “filosofia pratica”, con la conseguente “democratizzazione della vita quotidiana”, la fine di ogni mistica dei capi e degli apparati e di ogni esistenza “trascendente” di partiti ed organizzazioni totalizzanti.
Le tradizionali organizzazioni “storiche” del movimento operaio però, sia nei paesi a “socialismo reale” (dove si sono metamorfizzate in apparato portante di un tipo inedito di capitalismo burocratico di stato), sia nei paesi occidentali (dove si sono ormai imposte come amministratori delegati della forza-lavoro organizzata dentro il modo di produzione capitalistico), non possono avere alcun interesse ad un reale abbandono delle ideologie manipolatorie del Soggetto, del Fine e della Utopia Sintetica, in nome delle quali legittimano il proprio monopolio politico.
Se, d’altro canto, abbandonano le forme teoriche legate alla triade soggetto-fine-utopia sintetica, ormai ampiamente sbeffeggiata dagli intellettuali universitari e della cosiddetta “cultura d’avanguardia”, lo fanno per abbracciare forme di razionalismo critico, di ideologia sistemica, di scambio politico, ecc., che rappresentano soltanto l’altra faccia della manipolazione strutturale della realtà sociale.
In ogni caso, il discorso di tipo ontologico-sociale interessa loro ancor meno di quanto alla Chiesa interessi il messaggio evangelico delle origini. Per fortuna, però, la crescita della determinatezza ontologica delle individualità storiche nel tempo presente è un fenomeno di massa, e questa peculiare forma di “soggettività” è alla lunga incompatibile (a differenza, ed anzi in opposizione, di quanto dicono pessimisticamente i francofortesi) con le arroganti ideologizzazioni manipolatorie dei ceti politici cresciuti parassitariamente intorno al monopolio della “rappresentanza politico-sindacale” del movimento operaio.
Non c’è ovviamente in questo nulla di necessario, di fatale e di predeterminato. L’intensità e l’estensione delle individualità storiche nel tempo presente è un fatto ontologico-sociale (nel suo nesso dialettico fra il massimo della casualità nella collocazione sociale ed il massimo di particolarità che si dà l’individualizzazione cosciente di questa casualità), ma la possibilità che questo processo di individuazione porti al comunismo è appunto soltanto una “possibilità concreta”, e nulla di più.
In secondo luogo, non crediamo certamente che la forma filosofica del discorso che proponiamo, di tipo ontologico-sociale, e che traiamo esplicitamente dalla prospettiva teorica dell’ultimo Lukàcs, sia la “filosofia” definitiva, ultima, e “finalmente scoperta”, del materialismo storico e della critica dell’economia politica. Così come non crediamo, sul piano della riflessione epistemologica, ad un “metodo scientifico definitivo”, analogamente non crediamo ad “una forma filosofica del discorso definitiva”.
L’ontologia dell’essere sociale è quindi per lo scrivente in prima istanza una risposta determinata all’incorporazione del materialismo storico in una “grande narrazione” manipolatoria ed ideologica, in quella che abbiamo definito una “camicia di forza”, e come tale deve essere giudicata e considerata, non certo come una philosophia perennis cui fare appello contro il periodico ed eterno ritorno del sempre eguale “idealismo soggettivo”. Non crediamo certo, per altro, che Lukàcs sia andato molto più in là di un’impostazione provvisoria e largamente generica del problema di cui ci occupiamo.
Comunque, questo basta (ed avanza!) perché lo scrivente lo giudichi in perfetta coscienza come il maggiore filosofo marxista del secolo (essendo, appunto, compito del filosofo quello di impostare teoreticamente i problemi, non certo quello di “risolvere” le contraddizioni prodotte inevitabilmente dalla prassi dei soggetti storici concreti). Con questo riconoscimento, però, si può forse scrivere un capitolo della storia della filosofia del Novecento, ma si fa poca strada. In questo saggio non ritengo purtroppo di essere già in grado di fare dei passi avanti sulla via filosofica aperta dalla “Ontologia” lucacciana (la cui lettura ed il cui studio dovrò in larga misura dare per presupposti, cosa relativamente agevole, dato l’alto livello della traduzione italiana di Alberto Scarponi), e ripiegherò su di un compito più modesto, ed indubbiamente più facile: l’individuazione e la traccia di un percorso teorico che, partendo da contraddizioni filosofiche presenti nel pensiero di Marx, ed attraversando alcuni problemi teorici del marxismo tradizionale e dei punti alti del pensiero del Novecento (in particolare Heidegger e Bloch), sfoci infine nell’accettazione consapevole della prospettiva teorica lucacciana individuata come la migliore (o, se si vuole, la meno peggiore, e ci si scusi la cattiva espressione in lingua italiana) di cui possiamo disporre oggi.
Questo percorso teorico viene sviluppato in cinque parti, interconnesse, ma anche parzialmente autonome. Dall’impossibilità di un mero “ritorno a Marx” (prima parte), attraverso l’impossibilità di una mera “difesa del marxismo” (seconda parte), fino alla possibilità di una radicale riforma della forma filosofica del discorso con cui pensare il materialismo storico, in vista di un suo necessario sviluppo (terza, quarta e quinta parte).
Nella prima parte si affronterà, senza ipocrisie e senza voler difendere inutili “rendite di posizione”, la forma filosofica del discorso di Marx. Allo scrivente sembra si possano individuare in Marx tre differenti “discorsi filosofici”, che coesistono talvolta contraddittoriamente: un primo discorso, di tipo grande-narrativo (si tratta di una forma di teleologia sociale in cui un soggetto pieno garantisce con la permanenza della sua identità iniziale, in una temporalità cumulativa, omogenea e lineare, l’inevitabile realizzazione finale del suo progetto originario, dando luogo così ad un quadruplice mito, del soggetto, dell’origine, del fine e della trasparenza); un secondo discorso, di tipo deterministico-naturalistico (si tratta del fatto che Marx, profondamente influenzato dal concetto illuministico di “storia naturale”, pensa talvolta il suo progetto teorico sotto la dominanza dell’analogia con la struttura teorica delle scienze ottocentesche della natura, e dello stesso darwinismo); un terzo discorso, di tipo ontologico-sociale (in cui non c’è nessuna teleologia automatica della storia – solo il lavoro come “forma originaria” e “modello” è unità di causalità e teleologia –, nessun “paradigma della produzione”, nessuna grande narrazione, nessun determinismo naturalistico).
È evidentemente questo terzo “discorso filosofico” che deve essere valorizzato, sviluppato, arricchito ed aggiornato. In questo senso, il “ritorno a Marx” è del tutto possibile ed auspicabile. Tuttavia, essendo questa terza forma del discorso filosofico marxiano spesso mescolata con la prima e con la seconda, è meglio scoraggiare ogni facile illusione di un “ritorno” ad un Marx univoco, compatto, cristallino come acqua di fonte.
Nella seconda parte si effettuerà una lettura “orientata” delle avventure filosofiche del “marxismo”. Lo scrivente dà per scontato il fatto che fra pensiero marxiano e “marxismo” vi è una specifica discontinuità, quasi fisiologica, dovuta al ruolo teorico di Kautsky ed ancor più alle necessità di identità teorica della socialdemocrazia tedesca. Tutto questo è ormai ampiamente noto, e spesso è taciuto soltanto per malafede. Altre cose non sono però del tutto scontate, e vale forse la pena ripeterle.
In primo luogo, vi sarà una moderata, ma convinta, “difesa di Engels”, letto come pensatore originale e fecondo di contraddizioni assai utili, anche se datato. Engels è infatti molto spesso sottoposto ad operazioni di “squartamento teorico” molto strumentali. Isolando infatti lo Engels della “dialettica della natura” è infatti chiaro che lo si può far facilmente diventare il fondatore del “marxismo orientale” (il cosiddetto Diamat, fondato su di una gnoseologia del riflesso dell’essere nel pensiero e su una pseudo-ontologia della storia naturalizzata in nome di una – peraltro giusta – natura storicizzata).
D’altra parte, isolando l’Engels sostenitore della tesi sul «proletariato come soggetto storico erede della filosofia classica tedesca» lo si può far facilmente diventare il fondatore del “marxismo occidentale” (fondato sulla unità di soggetto ed oggetto, proletariato e storia, esattamente come la filosofia classica tedesca si basava sulla unità di soggetto e di oggetto, borghesia idealtipicizzata e storia razionalizzata dialetticamente). Lo scrivente ritiene che Engels non debba essere sottoposto ad incresciosi squartamenti filosofici isolando parti strumentalizzabili e che questo grande “classico” non abbia “fondato” proprio nulla.
In secondo luogo, vi sarà una cauta, forse meno convinta, ma sostanziale, “difesa del Lenin filosofo”. Lenin ha cercato una sua particolare via al matrimonio fra materialismo e dialettica, anche se poi, all’atto pratico, il “materialismo” è pensato sotto il primato della tesi gnoseologica del rispecchiamento, e la dialettica è pensata talvolta sotto il primato della contraddizione semplice. È possibile tuttavia spiegare questo fatto collegandolo alla congiuntura storico-politica di quegli anni, non certo per giustificazionismo storicistico, quanto per la necessità di “situare” correttamente il pensiero filosofico di Lenin. Vi sono però (almeno) due aspetti irrinunciabili nell’approccio filosofico di Lenin: il discorso di tipo ontologico-sociale determinato prevale in lui quasi sempre su quelli (pur presenti) di tipo grande-narrativo o deterministico-naturalistico; il programma di connessione elastica fra materialismo e dialettica è strutturalmente superiore alle posizioni differenzialistiche e sistemiche.
In terzo luogo, non vi sarà invece alcuna concessione, neppure periferica e di dettaglio, ai programmi di “salvataggio” di quanto ancora resta del “marxismo orientale” e del “marxismo occidentale”. Le differenze fra i due sono certo importanti sul piano della corretta ricostruzione degli eventi storici, ed è chiaro che, ad esempio, il “livello teorico” di un Karl Korsch non può essere seriamente paragonato a quello di uno Zdanov o di un Mitin. In sede però di bilancio teorico, l’aspetto principale è la sottolineatura della loro profonda e segreta solidarietà antitetico-polare, mentre secondario diviene l’aspetto del pur alto “livello di qualità” dei marxisti occidentali rispetto agli ideologi di partito confezionatori delle indigeste pillole del “materialismo dialettico” sovietico. Si insisterà anche sulla sostanziale sterilità dei tentativi di “liberalizzazione parziale”, di “integrazione” e di riforma delle strutture teoriche portanti dei due marxismi: il materialismo dialettico sovietico non può essere cambiato qualitativamente innestandovi sopra spezzoni esistenzialistici, positivistici, sistemici, così come il modello economico sovietico non può essere cambiato qualitativamente con riforme “efficientistiche”; il marxismo occidentale non può essere qualitativamente cambiato enfatizzando in modo ipertrofico, all’interno dell’unità soggetto-oggetto che lo caratterizza, il ruolo del “soggetto”, come l’esperienza del cosiddetto “operaismo italiano”, tanto ricca di insegnamenti, mostra bene a chiunque ne voglia veramente trarre un bilancio teorico.
In quarto luogo, infine, alla luce delle precedenti considerazioni, si insisterà ancora sul fatto che senza l’abbandono esplicito e convinto di moltissime “rendite di posizione” marxiste non ci può essere né un confronto produttivo fra materialismo storico ed i cosiddetti “punti alti del pensiero borghese” né una ricostruzione filosofica della “dicibilità” della critica marxiana dell’economia politica nell’attuale situazione storica.
Nella terza parte si prenderà in esame l’insieme del pensiero di Martin Heidegger come punto alto del pensiero borghese novecentesco, degno di essere “confrontato” con il materialismo storico. La filosofia di Heidegger è considerata, in primo approccio, come una grande metafora teorica di una tragica situazione pratica del nostro secolo, l’unità fra alienazione ed intrascendibilità del modo di produzione capitalistico, che però Heidegger non nomina mai, preferendo espressioni come “epoca dell’immagine del mondo” e come “coronamento” della storia della metafisica occidentale.
L’interrogazione heideggeriana del marxismo non è esplicita come in Max Weber, ma è quasi sempre più radicale. È facile accorgersi di questo, non appena vengano evitate le facili etichettature di Heidegger come “vecchio conservatore” (Habermas), le interpretazioni esistenzialistiche, neo-razionalistiche ed estetico-nichilistiche, molto diffuse in Italia, oppure i frettolosi confronti e conciliazioni con Marx o con il marxismo, anch’essi presenti nella letteratura filosofica secondaria. In Heidegger l’interrogazione radicale della società capitalistico-borghese è caratterizzata da una significativa evoluzione da un primo momento, in cui la critica è condotta soggettivisticamente, sotto il segno della categoria di “anonimità” (si veda l’analisi della trasformazione del Wer in Man in Essere e tempo, della chiacchiera, della curiosità e dell’equivoco), ad un secondo momento, in cui la critica è condotta ontologicamente, sotto il segno della categoria di “tecnica” come vera e propria “im-posizione anonima” (Gestell). Il passaggio dalla soggettivistica critica alla chiacchiera anonima (Gerede) alla critica ontologica della im-posizione anonima (Gestell), attraverso il link intermedio del concetto di “immagine del mondo” (Weltbild), come superamento dell’incantesimo epistemologico dell’opposizione polare fra soggetto ed oggetto, è una metafora filosofica che interroga in modo radicale il capitalismo come unità (in Heidegger non dialettica) di alienazione e di intrascendibilità.
Tuttavia, questa grande unità teorica non dialettica di alienazione e di intrascendibilità, pur essendo in grado di trasformare l’alienazione in un concetto ontologico (alle soglie dunque della giusta equazione fra forma di valore ed alienazione, tipica della critica dell’economia politica) e soprattutto di legare insieme sia il “capitalismo occidentale” sia il cosiddetto “socialismo reale”, non contiene, ma anzi evita con pervicace e voluta cecità l’esame dialettico della reinterpretazione delle possibilità contenute nel passato. Sostituendo infatti allo storicismo (cui vuole opporsi) una sorta di fatalistico destinalismo (che altro non è se non un’inversione di 180% dello storicismo, e dunque uno storicismo rovesciato e cambiato di segno), il pensiero di Heidegger decade in una storia, storicisticamente predeterminata ed unilineare, della caduta destinale da Platone a Taylor, da Aristotele a Stalin, ed in questo modo l’“intrascendibilità della alienazione” viene legittimata in modo del tutto metafisico, fino a cadere sotto il livello dell’analisi weberiana della razionalizzazione crescente, che è anch’essa una forma di destinalismo, linguisticamente più sorvegliato e mille volte più articolato nei dettagli, anche se meno rigoroso nell’impianto teorico e nell’interrogazione filosofica del presente.
Nella quarta parte verrà interrogato il pensiero di Ernst Bloch, visto sotto l’angolatura dell’opposizione determinata al destinalismo heideggeriano. Bloch è un pensatore che mette al centro proprio quella «reinterpretazione delle possibilità contenute nel passato» che è appunto estranea sia ai paradigmi filosofici “marxisti” sia alla critica differenzialistica di questi ultimi. La blochiana distinzione strategica fra «non-contemporaneità» ed «arretratezza» (con la scelta esplicita della prima contro la seconda) permette una vera resa dei conti con la temporalità storicistica e con il suo “supporto sostanziale”, l’umanesimo astratto. È molto importante, infatti, che il multiversum blochiano sia un concetto filosofico che rompe realmente sia con le strutture teoriche grande-narrative che con quelle di tipo deterministico-naturalistiche, cui si è fatto sopra cenno. L’importanza teorica del pensiero blochiano non si ferma certo qui.
In primo luogo, Bloch è un pensatore che attua una “centralizzazione teorica” della critica della religione come premessa immanente, logico-storica, della critica dell’economia politica. La critica della religione (e si leggano Religione in eredità ed Ateismo nel Cristianesimo) non deve essere scambiata per la negazione astratta dell’«esistenza nel cielo» di una «entità cosale chiamata Dio», in quanto la critica positivistico-ingenua della religione sta al materialismo storico come l’economia “razionale” ricardiana sta alla critica dell’economia politica.
In secondo luogo, Bloch è il pensatore che inserisce apertamente il giusnaturalismo come fonte e parte integrante del materialismo storico (e questo non è “innocente” poiché, per esempio, nell’elencazione delle “tre fonti”, Lenin si era scordato del giusnaturalismo, che non ha certo uno “statuto epistemologico” inferiore a quello della progettualità del socialismo utopistico). In Bloch (si veda Diritto naturale e dignità umana) il giusnaturalismo è certo una “filosofia pratica” che deve servire per quella scienza della liberazione che egli chiama l’«ortopedia del camminare eretti», ma finisce con il diventare anche (e soprattutto) la negazione teoretica determinata delle letture destinali, pessimistiche e disperate della società borghese alla Heidegger ed anche alla Horkheimer e Adorno.
In terzo luogo, Bloch è il pensatore che riesamina radicalmente e ridefinisce integralmente la nozione di utopia e di «agire utopico», modificando la nozione classica di «progettualità astratta da tavolino» contrapposta al cosiddetto «movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti, ed anche la nozione di «sogni impotenti ed irrealizzabili contrapposta alla «conoscenza scientifica delle leggi oggettive del movimento della storia». Non bisogna dimenticare mai che «l’utopia blochiana si occupa solo del presente», mentre la nozione regressiva ed infausta di utopia come progettualità astratta è da trovare semmai nel tentativo, sempre frustrato, di proiettare nel futuro un modello statico di «economia razionale.
In quarto luogo (ed è questa una rilevante novità, che non permette frettolose etichettature e “stroncature” di Bloch come “Schelling marxista”) Bloch è, soprattutto, il pensatore che infrange l’unilaterale polarità astratta fra il marxismo orientale (che sostiene la dialettica della natura, e respinge la considerazione unitaria del nesso soggetto-oggetto) ed il marxismo occidentale (che sostiene l’unità soggetto-oggetto, e respinge la dialettica della natura).
In Bloch (e si vedano opere come Soggetto-Oggetto, e soprattutto Das Materialismusproblem) la specifica, originale compresenza dei temi della dialettica della natura e dell’unità soggetto-oggetto non deve essere interpretata come eclettico pasticcio e concordismo ad ogni costo, ma come un’originale via filosofica che sblocca le polarità irrigidite.
In quinto luogo, infine, Bloch è seriamente orientato verso una fondazione ontologica della prassi, come risulta evidente esaminando Experimentum mundi, la “summa” sistematica blochiana. Bloch vede bene come senza ontologia la prassi non può essere sensata ed orientata, e diventa arbitraria, manipolatoria, soggettivistico-astratta. Egli connota la prassi come «ruotar fuori al di là dell’immediato», e come momento immanente alla temporalità che scioglie ogni trascendentalistica fissità del soggetto, che non può più essere concepito come originario (come avviene, ad esempio, nelle concezioni neo-utilitaristiche e neo-contrattualistiche).
E, tuttavia, lo scrivente ritiene che in Bloch il non concepire la prassi come “lavoro” porta necessariamente ad una grande indeterminatezza del concetto di prassi stessa, fino a rovesciarla inevitabilmente nel suo contrario, la prassi come contemplazione. Questo può certo avvenire contro le esplicite intenzioni di Bloch, in quanto in lui l’oscillazione fra “sogno di una cosa” e “lotta per realizzare il sogno” cade quasi sempre sul secondo termine, ma è aperto il varco teorico ai blochiano-contemplativi che possono legittimamente enfatizzare unilateralmente il primo termine.
Nella quinta, ed ultima parte il pensiero ontologico di Lukàcs viene interrogato proprio a partire dalla “mancanza” che lo scrivente crede di individuare nello sforzo ontologico blochiano: la centralizzazione di un concetto di prassi storicamente più determinato, che sappia correlare ontologicamente la specificità delle individualità concrete particolari con le legalità “oggettive” del movimento del modo di produzione capitalistico. Parlando di Lukàcs, è evidente che non ci si riferisce affatto al “primo Lukàcs” (che in Storia e Coscienza di Classe ha scritto il capolavoro teorico del “marxismo occidentale”, la cui tradizione riteniamo debba essere invece integralmente abbandonata), e neppure al “secondo Lukàcs (che nella Distruzione della Ragione ha tentato un impossibile compromesso con gli aspetti “razionalistici” del “marxismo orientale”, mentre riteniamo che quest’ultimo debba essere visto come il correlato antitetico-polare dell’irrazionalismo borghese, e per nulla affatto un “principio superiore” ad esso), ma a quello che potremo per brevità definire il “terzo ed ultimo Lukàcs”, portatore di una proposta aperta di ricostruzione della forma filosofica del discorso del materialismo storico sulla base esplicita di una ontologia dell’essere sociale, individuato nella sua determinatezza e nella sua storicità.
È il carattere “aperto” della proposta che soprattutto interessa allo scrivente, cui non interessa certo fare una monografia apologetica sull’ultimo Lukàcs, né tantomeno sottoscrivere tutto quanto Lukàcs ha detto o scritto (a partire dal problema della cosiddetta “natura sociale dei paesi a socialismo reale”, che Lukàcs, certo anche per ragioni di età e di esperienza storica tendeva a considerare troppo ottimisticamente). Altre, e ben più “radicali”, sono le ragioni che spingono verso la prospettiva teorica dell’Ontologia lucacciana.
In primo luogo, non ci si stancherà mai di enfatizzare, fino alla noia, l’importanza di quella operazione chirurgica ben riuscita che è il rifiuto, simultaneo e simmetrico, dei “marxismi” orientale ed occidentale. In Lukàcs questo non è sempre motivato con la chiarezza che sarebbe auspicabile (ed integrazioni sono dunque possibili e necessarie), ma ciò che conta è la messa in guardia dalla sterilità che nasce dal pensare di poter giocare l’uno contro l’altro, di “rilanciare” in qualche modo cosmologie comuniste, ditirambi prometeici del proletariato, enigmi risolti della storia, ecc.
In secondo luogo, fondamentale è la connotazione strategica della corrente principale del pensiero filosofico borghese del Novecento come solidarietà antitetico-polare fra neo-positivismo ed esistenzialismo. In Lukàcs questo giudizio ha tutte le caratteristiche della determinatezza e della specificità, mentre altri (ad esempio Martin Heidegger), che pure capiscono bene il nesso intimo della considerazione operazionalistica del mondo fisico e biologico, da un lato, e della risoggettivizzazione esistenzialistica del “senso da dare alla vita” sulla base fatale di un “mondo scientifico” autonomizzato ed operazionalizzato, dall’altro, pervengono ad un giudizio analogo sulla base ambigua di una filosofia teleologica e destinalistica della storia. Inoltre, le osservazioni lucacciane (su Carnap, Wittgenstein, la teologia contemporanea, ecc.) sono essenziali per respingere l’ideologia della “integrazione filosofica” di presunti “pezzi mancanti” al materialismo storico, e la sterilità di innesti artificiali che vengono spesso ingenuamente fatti sul “discorso marxista” che resta grande-narrativo e deterministico-naturalistico.
In terzo luogo lo scrivente condivide la centralizzazione, strategicamente fondamentale, nel “lavoro” (come Urform, forma originaria, e come Vorbild, modello, dell’agire umano concreto, superamento della polarità astratta fra causalità e teleologia, necessità e casualità) dell’approccio ontologico-sociale. Sono certo possibili sbandamenti verso sciagurate “filosofie generali del lavoro”, teorie generali dell’azione sociale (valide in ogni tempo ed in ogni luogo, dalle caverne alla fabbrica informatizzata), riferimenti etico-religiosi al “valore del lavoro”, ecc.
Questi fraintendimenti, potenzialmente laburistico-autoritari (che provocano necessariamente reazioni polarmente opposte in coloro che contrappongono il lavoro come disciplinamento sociale autoritario al gioco come realizzazione dell’essenza desiderante, perverso-polimorfa, dell’Uomo) devono essere considerati in parte inevitabili, data l’ambiguità semantica del termine “lavoro”, ed in parte giustificabili, dato il peso nefasto delle ideologie “lavoristiche” del passato.
Tuttavia, se si vuole realmente, e non solo a fior di labbra, passare dal materialismo storico come “discorso sulla forma di merce” (la cui “ontologia” è appunto una “grande narrazione”) al materialismo storico come “discorso sulla forma-lavoro capitalistica”, occorre essere consapevoli della necessità di una considerazione ontologica (ovviamente, sociale e storicamente determinata) del lavoro. Questo non potrà che essere uno sforzo collettivo, di “scuola”.
In quarto luogo, vi è nell’Ontologia lucacciana una considerazione flessibile, ma materialistica, del concetto di “riproduzione”. Occorre evitare, su questo punto, due opposti antitetico-polari: la vecchia “topologia rigida” che mette “sotto” la produzione materiale come “struttura” e colloca “sopra” tutto il resto come “sovrastruttura”, da un lato; la dissoluzione della produzione materiale nel grande fascio multicolore e pittoresco delle “pratiche riproduttive”, in cui animatori teatrali, cuochi, operai metalmeccanici, ingegneri biogenetici, giornalisti, capitalisti, casalinghe ed insegnanti trainano un carro carnevalesco chiamato “sistema sociale complesso”.
La “produzione” deve essere invece ricentralizzata come “pratica riproduttiva dominante”, che comanda le altre in modo flessibilmente dialettico, e che rigerarchizza secondo un andamento ciclico e determinato, la cui caratteristica non è mai quella teleologica di “precipitare in un punto solo”.
In quinto luogo, vi è nell’Ontologia lucacciana (ed è il caso di dire: finalmente!) un concetto corretto di “ideologia”. Si tratta proprio della «esistenza reale del momento ideale» della riproduzione sociale nel modo di produzione capitalistico contemporaneo. A parere dello scrivente l’importanza del momento ideologico non può essere soltanto ricavata da un’antropologia filosofica dell’essere umano come “animale simbolico” (che pur resta necessaria), ma deve essere correlata strettamente a determinati processi storici specifici, quali la dominanza del plusvalore relativo (Aglietta), la perdita di senso del lavoro umano (Braverman), ecc., che richiedono una trattazione non francofortese dell’intera questione. Ci sembra che in Lukàcs vi siano i presupposti teorici per andare avanti su questa strada.
In sesto luogo, infine, vi è in Lukàcs una considerazione ontologico-materialistica della “estraneazione”. Se ne sentiva il bisogno. Per alcuni decenni il concetto di “estraneazione” è stato usato in modo psicologistico e generico come sinonimo di “disagio esistenziale” (diventando una sorta di chiave lessicale per le corporazioni professionali dei filosofi e soprattutto degli psicologi), provocando la reazione, antitetico-polare, di coloro che vollero addirittura cancellare la parola dal linguaggio marxista (e si pensi soltanto a Louis Althusser). Alla fine, il gioco era diventato “a somma zero”. In Lukàcs la dialettica fra individuo, genere e specie (che contiene ovviamente anche il momento della “estraneazione”) non porta mai a dichiarazioni, apparentemente estremistiche e gratificanti, ma generiche, sulla “incompatibilità ontologica” del capitalismo con l’uomo o con la natura “in generale” (come avviene in posizioni che vanno dai coccodrilli borghesi del Club di Roma ai più sinceri e stimabili ecologisti antiborghesi apocalittici), ma sfocia in una concezione storico-ontologica dello “statuto” della estraneazione. Soprattutto due punti sono messi in evidenza.
Da un lato, l’individualità generica e concreta dei singoli cresce, nel capitalismo, sulla base astratta della casualità della collocazione sociale non più sostantivizzata dai ceti e dalle corporazioni, ed è appunto questo carattere ontologico-specifico della individualità che entra in conflitto con le esigenze strutturali di manipolazione della riproduzione del sistema capitalistico, la cui logica è appunto quella di reprimere, deviare, soffocare ogni reale tendenza dell’individualità concreta all’universalità reale del genere umano (e vi è qui un vero progresso qualitativo in rapporto alle concezioni sulla “disumanità astratta” del capitalismo che “mercifica tutto” o che semplicemente “manipola” attraverso i mass-media).
Dall’altro lato, la differenza ontologica fra individualità (sviluppata fin che si vuole) ed universalità del genere è mantenuta, contro ogni organicismo, trasparenzialismo, mito della “ricomposizione integrale” fra pubblico e privato, in modo da fondare una sorta di “individualismo comunista” che leghi insieme il rifiuto di ogni atomismo borghese con il rifiuto di ogni olismo sociale organicistico. La lotta delle classi sarà sempre più una lotta di individui coscienti, sempre meno disposti ad inneggiare a duci e ducetti “operai”, capi carismatici ed individui cosmico-storici, grandi timonieri e leaders saggi e preveggenti. Si gioca qui una “partita filosofica” (soprattutto in Italia) non meno importante della partita vinta dalla nazionale italiana ai mondiali di calcio.
Il percorso filosofico che qui si è riassunto, per comodità del lettore, è ovviamente un tipico caso di “posizione teleologica” in filosofia, ed è soggetto a tutte le determinazioni ontologiche della forma-modello di “lavoro”. Se esso presenta errori ontologici di fondo, sia nell’interpretazione storiografica di Marx e del marxismo successivo, sia soprattutto nella praticabilità concreta della prospettiva che vuole aprire, esso fallirà, e non potrà avere sviluppo.
Lo scrivente non è affatto preoccupato dalle inevitabili superficialità che non possono non risultare da una trattazione “enciclopedica”, che mette in campo pensatori del calibro di Marx, Engels, Heidegger, Bloch, Lukàcs, ecc. Questo è dato per scontato, ma non è molto grave, data la disponibilità in lingua italiana di ottime monografie specialistiche su questi pensatori (che verranno spesso peraltro richiamate in nota o nel testo, in modo che il lettore interessato possa approfondire per suo conto). Il vero problema, ovviamente, è soltanto quello della effettiva e concreta praticabilità filosofica della prospettiva teorica che qui viene indicata.
Sulla pars destruens vi sarà probabilmente un accordo quasi generale. Sono pochi coloro che sostengono apertamente oggi concezioni grande-narrative, deterministico-naturalistiche, o che difendono il materialismo dialettico staliniano, oppure forme ingenue e “cumulative” di storicismo.
L’opposizione netta dello scrivente all’«operaismo» potrà sembrare a qualche lettore maniacale ed eccessiva, ma bisogna mettere in conto la specificità della situazione italiana, in cui la matrice teorica “operaista” ha dato luogo a forme di ultra-soggettivismo di tipo neo-gentiliano. Heidegger interessa per ora in Italia quasi soltanto alle varie forme di nichilismo di tipo post-moderno, e Bloch è letto molto spesso soltanto dai teologi, in forma generalmente depotenziata e concordistica. Inoltre, molte opere che interesserebbero il nostro argomento non sono state ancora tradotte, e costringono così a sapienziali e faticose letture specialistiche in lingua tedesca.
È sulla pars costruens che invece vi saranno maggiori difficoltà. L’Ontologia dell’Essere Sociale resta (nonostante l’ottima traduzione) un libro poco letto e poco studiato. Lo scrivente ritiene tuttavia che il lungo festival del nichilismo soggettivistico stia per finire, le luci si stiano spegnendo, e professa in proposito un sobrio e moderato ottimismo.
Costanzo Preve
|