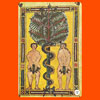|
|
Prefazione
di
Fernanda Mazzoli
Un libro pensato innanzitutto per gli studenti e gli insegnanti si espone al rischio di appiattirsi su un taglio manualistico prettamente informativo – opzione d’altronde assolutamente legittima, dato il contesto – che abbina alla proliferazione dei dati di varia natura la loro semplificazione concettuale e l’oscuramento della tela di fondo su cui essi si dispongono.
La finalità pedagogica, non sempre correttamente intesa, può spingere poi in direzione di un’attualizzazione brutale, cioè non opportunamente mediata sul piano culturale e storico, dei temi e problemi passati in rassegna, nell’illusorio per quanto comprensibile tentativo di rendere accattivanti argomenti indiscutibilmente ardui.
Ne risulta troppo spesso una superficialità vanamente mascherata dalla quantità delle informazioni e dal sussiego della forma espositiva che cerca di coprire attraverso la profusione del lessico specialistico la mancanza di originalità. Sono libri destinati al consumo scolastico, numi tutelari per verifiche e punteggi per gli studenti, puntello alla memoria per i docenti. Strumenti sicuramente utili agli uni e agli altri, ma nulla di più.
Un libro insegna nella misura in cui segna, cioè lascia un segno nello spirito di chi lo legge e non semplicemente sul registro, a maggior ragione se si propone di affrontare questioni filosofiche, vale a dire questioni che investono la verità, il bene, il significato del nostro essere al mondo, la coraggiosa contemplazione delle cose al di là del loro apparire, per dirla con Eraclito cui non a caso Massimo Bontempelli ha dedicato uno studio, Eraclito e noi, di prossima ristampa.
Ora, questo suo testo si inscrive a pieno titolo nella categoria dei libri che incidono, che cadono con la lama affilata di una rigorosa riflessione e di un’inesausta passione intellettuale su una materia tanto primaria ed essenziale, quanto maltrattata e trascurata.
E squarciano il velo, o meglio il sudario, dentro il quale essa è stata occultata, ai fini di rimuoverla dal piano filosofico per lasciarla andare alla deriva del gusto individuale o di un’estemporanea esperienza privata. Ci troviamo dunque di fronte ad un libro coraggioso, proprio come Eraclito richiedeva alla filosofia di essere.
Evidentemente, si tratta di una materia pericolosa, se è stata sottratta agli sguardi dei più e privata della dignità di potersi avvalere di credenziali razionali e se il suo disseppellimento e successiva riabilitazione hanno richiesto una buona dose di audacia che mai, d’altra parte, ha difettato all’autore, specialista in operazioni filosofiche controcorrente, nel recupero e approfondimento di temi e problematiche rimosse, “relitti” di una sapienza millenaria che l’antica Grecia in primis ha regalato all’umanità e che l’era della post-verità ha relegato nel cantuccio delle curiosità erudite nel migliore dei casi, quando non ne ha decretato la morte per irrilevanza cognitiva e inutilità sociale.
Dunque, è a un percorso non rassicurante che Massimo Bontempelli chiama il lettore, sospinto dal suo argomentare pacato ma serrato, sostenuto da una lingua mirabilmente chiara anche quando si addentra in concetti complessi, ad abbandonare le false certezze incuneate nelle idee dominanti che hanno pervaso il corpo sociale, facendosi forti dell’autorevolezza scientifica in ambito accademico e dell’allineamento al sentire comune nell’ambito della vita quotidiana.
Basterebbe solo questo per raccomandare la lettura delle pagine che seguono, poiché ciò di cui c’è oggi disperato bisogno è di andare oltre uno specchio che rinvii sempre la stessa immagine, confermandoci che non vi è nessun’altra realtà, poiché tale oggetto «per mostrare tutto ciò che appare non rivela alcunché di ciò che non appare», come sottolinea icasticamente il filosofo.
E quel che non appare è, per esempio, che la distinzione fra bene e male è un oggetto di conoscenza e che averlo estromesso come tale dal pensiero della modernità ha finito per oscurare gli stessi fondamenti etici del vivere umano e della convivenza sociale.
Quel frutto proibito – che è proprio la conoscenza del bene e del male – che i nostri progenitori gustarono nel giardino dell’Eden, acquisendo una sapienza che li ha strappati all’immediatezza della vita biologica e condannati contemporaneamente alla consapevolezza della mortalità sembra avere smarrito quell’aspetto invitante e quel sapore che persero loro e i loro discendenti, gettandoli nudi e tremanti nelle tempeste della vita e della storia. Insomma, il prezzo pagato per la conoscenza è stato alto, ma attraverso di esso l’umano è diventato pienamente tale. Questa capacità di discernimento così strettamente legata alla morte, ne costituisce anche un limite, un terreno in cui disputarle spazio: vita e morte si affrontano sotto le sembianze di Bene e Male, là dove il primo costituisce una presa di posizione per la vita contro la morte che avanza nel cuore stesso della vita, distruggendo quegli scopi – e la capacità di averne cura e di riconoscere quelli altrui – attraverso cui si esprime la vitalità.
L’estromissione dal terreno della ragione del Bene e del Male e il loro confinamento in una sfera residuale più o meno religiosa o mitica ha dunque aperto la strada al demone della distruzione che divora la vita, alternando come in un gioco di maschere il guizzo feroce della pura malvagità al ghigno cinico e disperato del nichilismo o alla pacatezza levigata e fredda dell’homo economicus.
Seguendo le vicissitudini del suo oggetto di ricerca, Bontempelli ci guida dall’antico mito biblico che in forma narrativa coglie una grande verità umana alla speculazione filosofica che, a partire dai Greci, afferma l’oggettiva razionalità del Bene fino al punto di snodo cruciale situato fra XVII e XVIII secolo, in quella temperie culturale che vide imporsi la Rivoluzione scientifica, l’Illuminismo e il liberalismo.
L’autore opera qui una scelta particolarmente felice, e di notevole rilievo didattico, approcciando il tema da un’angolazione abbastanza inusuale, ovvero mostrando l’enorme e misconosciuta influenza esercitata da pensatori considerati di secondo ordine e pertanto quasi sempre trascurati dalla manualistica scolastica: i fisiocratici – Quesnay, Sieyès, Condorcet – e Benjamin Constant, più studiato a scuola (e più in un qualche corso monografico universitario che al Liceo) come autore romanticheggiante di Adolphe piuttosto che come teorico liberale.
Scelta felice e significativa più di quel che non appaia, visto che ci spinge a porre una problematica affatto secondaria: e se proprio gli autori “minori” fossero gli interpreti privilegiati dello spirito del tempo, capaci di accoglierne stimoli, domande e tendenze e di rielaborarli in modo da tematizzarli e strutturarli in una visione organica, capace di innalzarli sul senso comune?
Problematica non peregrina, se si considera l’impatto sulla nostra società dei think tanks, centri studi animati da intellettuali di non grande richiamo (e certamente di levatura culturale assai più modesta di quella dei filosofi francesi testé citati), potenti quanto poco noti canali di formazione – e de-formazione – dell’opinione pubblica.
Trattandosi di gruppi organizzati e finanziati, l’analogia con i fisiocratici si arresta qui, ma induce ad una stimolante riflessione sul ruolo dirompente – sul medio-lungo periodo – esplicato da idee elaborate da pensatori considerati marginali rispetto ai grandi nomi consacrati dalla tradizione accademica, la cui trattazione, pertanto, viene trascurata nei programmi scolastici.
È, inoltre, merito non secondario di questo libro di Bontempelli non solo avere magistralmente dimostrato come essi abbiano giocato un ruolo determinante nel mettere a punto quella razionalizzazione irrazionale che ha finito per essere la carta d’identità del mondo in cui viviamo, ma avere fornito al lettore una loro accurata scheda biografica, attenta particolarmente al loro rapporto con i circoli culturali dell’epoca e gli eventi pubblici.
Un’antinomia difficile da leggere, quella della razionalizzazione irrazionale, perché vi sguazziamo – e vi affondiamo – come pesci nell’acqua, come se fosse il nostro ambiente naturale ed invece è l’esito solo apparentemente paradossale di una modernità che ha abbandonato le sue premesse – e promesse – emancipatrici.
Il trionfo della capacità di calcolo, di previsione, di precisione, di una complessiva efficacia operativa ha prodotto l’universo tecnico in cui viviamo che non ha altri scopi se non il proprio incremento, finendo per fare coincidere il valore con l’efficacia stessa. Gli umani diventano una articolazione di questo razionalissimo apparato, con conseguente espropriazione delle proprie azioni che hanno valore unicamente se incorporate in tale apparato, macchina complessiva del comando sociale, nonché inevitabile compressione delle proprie potenzialità autenticamente creative, ovvero della libertà.
Condizione ben riassunta dalla bieca, anzi rivoltante, definizione di capitale umano di largo consumo nella scuola attuale, sempre più orientata attraverso la didattica delle competenze, la digitalizzazione ed i percorsi di Alternanza scuola-lavoro (ora Percorsi per le Competenze Trasversali) ed Orientamento ad addestrare rotelline per il suddetto apparato.
Il divorzio fra ragione e valore degli scopi dell’esistenza umana consumato da fisiocrati e pensatori liberali fra XVII e XVIII secolo e perfezionato da Weber cento anni dopo, come ogni separazione non consensuale ha mietuto qualche vittima: una di esse è proprio la distinzione fra bene e male, vita e morte.
L’orizzonte della morte è stato rimosso o assorbito in un compiaciuto nichilismo, il bene è stato convertito in efficacia, oppure, nella sua versione più derisoria, in bene di consumo sul mercato della propaganda politica in cui coincide con l’adesione incondizionata a campagne di mobilitazione contro i “nemici” in agguato, identificati come “male assoluto”, specie quando non condividono l’entusiasmo per la democrazia (il)liberale e l’economia capitalistica.
Tutto quanto è fondamentale per l’uomo – è, per l’appunto, questione di vita o di morte – è stato estromesso dall’orizzonte storico attuale ed esiliato, se non negato, nella sfera privata dalla quale emerge spesso sotto forma di sofferenza esistenziale, né potrebbe essere diversamente: l’amputazione che l’essere umano ha subito sanguina come lacerazione sotterranea, al di sotto della soglia della consapevolezza.
Ed è nell’urgenza di favorire la maturazione di tale consapevolezza che l’elaborazione teoretica dello studioso si incontra con la sollecitudine del docente (Massimo Bontempelli ha affiancato all’attività di ricerca l’insegnamento liceale, vissuto da lui in chiave di impegno civile), particolarmente attento all’inquietudine, agli interrogativi, alle domande di senso di coloro che si affacciano alla vita adulta e alla necessità di fornire loro una strumentazione rigorosa ed autenticamente razionale, perché rispettosa della totalità del reale, per farvi fronte. Cassetta degli attrezzi utile quanto mai anche agli insegnanti, sempre più schiacciati tra acritica accettazione di una “innovazione” didattica imposta dall’esterno e tutta giocata sul terreno delle nuove tecnologie ed un inerziale rimpianto della perdita dei valori da parte delle giovani generazioni.
Affrontare un tema dalle forti connotazioni etiche coinvolgenti nuclei vitali del presente comporta, infatti, il rischio di una rinuncia all’inquadramento esaustivo del problema per il più comodo approdo recriminatorio su tempora e mores.
I tempi, invece, qui sono ben messi a fuoco: sono i tempi lunghi – marcati, malgrado le contraddizioni interne, da un significativo filo conduttore – della gestazione e del parto di un modello di società puramente economica: dall’individuazione ad opera di Quesnay del Prodotto netto come autentica espressione delle risorse di cui una società dispone, alla fiducia di Condorcet che tutti i problemi lasciati irrisolti da religione, filosofia e politica saranno chiariti dal sapere matematico e sperimentale, all’ipotesi di Sièyes di un futuro in cui la capacità di generare ricchezza supererà in importanza tutte le altre umane facoltà, alla coincidenza in Constant fra bene sociale e libero scambio di risorse prodotte privatamente, al disincanto del mondo individuato da Weber come prodotto dello sviluppo industriale e scientifico con susseguente ripiegarsi della morale in una sfera residuale che pertiene alla singolarità della coscienza, emerge un orientamento comune.
Questi autori hanno cucito, pur con fili diversi, quel tessuto della razionalità strumentale che assume come proprio fondamento e al tempo stesso finalità calcolo e quantità, dimediando il campo di intervento della ragione stessa e, in tal modo, immiserendo l’esistenza sociale ed individuale.
Essi hanno contribuito ad una rilevante trasformazione della mentalità collettiva, in direzione dell’universalizzazione delle relazioni tecniche, con il suo corollario in termini di divisione del lavoro e di rapporti sociali.
Il culto fisiocratico del prodotto netto e dell’economia ha percorso in due secoli e mezzo una lunga strada che è sfociata nell’universo della merce che ben conosciamo: un universo il cui scopo è la crescita illimitata di denaro, cioè di un mezzo: esempio estremo e lampante della razionalizzazione irrazionale, esito controverso e paradossale di una modernità tradita, in quanto da tale processo è la ragione per prima ad uscirne umiliata.
Universo che rinvia l’immagine deformata di un maccheronico paradiso perduto nel Paese di Cuccagna, ove non esistono più frutti proibiti, perché basta tendere una mano per toccare l’oggetto del desiderio, in un’illusione di immediatezza e pienezza appena scalfita dal prezzo da pagare, solitamente assai più a buon mercato di quello che toccò saldare ai nostri progenitori e senza la remora di un serpente tentatore occhieggiante da dietro uno scaffale, perché lo abbiamo già ucciso e digerito e, in caso contrario, potremmo sempre valutare di comperarlo: un paradiso di cartapesta pronto a scivolare nell’Inferno dell’insignificanza.
Mettere a nudo con argomentazioni razionali piuttosto che con moralistiche denunce in un testo rivolto innanzitutto al mondo della scuola la tragica incongruenza di una società costruita sull’idolatria del campo economico e sulla sua illimitata espansione a discapito degli altri (che esso dovrebbe servire) traduce una scelta educativa dal segno inequivocabile ed anche un invito ai docenti a non abbandonare il loro magistero critico, la cura della formazione di un essere umano e non del pezzo intercambiabile dell’ ingranaggio produttivo-tecnologico.
La conoscenza del bene e del male è stato pubblicato una prima volta nel 1998: nel giro di venticinque anni – lo spazio di una generazione – la potenza e la pervasività dell’apparato tecnico- scientifico sono aumentate a dismisura, al punto da pretendere ad una sorta di naturalità che ne offusca genesi storico-filosofica e contestualizzazione nel modo di produzione capitalistico: insomma, una seconda natura che nelle distopie transumanistiche potrebbe addirittura divenire una prima natura, o la sola. É diventato pienamente il nostro orizzonte storico di cui Weber affermava la intrascendibilità con la nota metafora della gabbia di acciaio.
Ora, la riflessione di Bontempelli aiuta a riportare in un ambito razionale un fenomeno – l’intelligenza artificiale – su cui attualmente sono appuntati i riflettori: per gli uni straordinaria risorsa che aprirà nuove strade all’umanità, forse oltre il concetto stesso di umano, per gli altri mostro tentacolare che ne sancirà il definitivo asservimento alla logica della macchina, fino alla sostituzione o all’ibridazione. In entrambi i casi, assistiamo ad una enfatizzazione di questo sistema di automazione che ne sottolinea il carattere di dirompente novità, di scoperta epocale in grado di imprimere una svolta senza precedenti alle nostre vite, al modo di studiare, lavorare, interagire con il mondo. In realtà, l’intelligenza artificiale rappresenta la realizzazione all’ennesima potenza di quella capacità previsionale e di calcolo nel quale siamo già immersi da molto tempo, l’apoteosi di quell’efficacia che già informa l’apparato scientifico-tecnologico, lo strumento più rifinito di una teleologia sociale puramente quantitativa, anzi finalità in sé, laddove il mezzo ha fagocitato tutto il resto.
L’individuazione di questa continuità assume particolare rilievo se additata criticamente agli studenti, se proposta da un docente desideroso lui per primo di comprendere quello che non si vede nello specchio come tema di riflessione capace di coniugare il passato di una secolare elaborazione filosofica con il presente di tecnologie, la cui potenza operativa si impone con tutto il prestigio di una complessa ed avveniristica intelaiatura, mentre la sua ratio riposa su operazioni intellettuali piuttosto semplici. E su un ossimoro che ci riporta ancora una volta al processo di restringimento della ragione, al suo abbandono di cruciali territori dell’umano.
Come rifiuta la facile invettiva moralistica, così Bontempelli offre una lezione di lucidità particolarmente preziosa in un momento in cui alla tracotanza del totalitarismo tecnico- scientifico, cuore pulsante del modo di produzione capitalistico, verrebbe, per istinto di ribellione e per disperazione di poter mai uscire dalla famosa gabbia, da rispondere con il vagheggiamento di un passato idealizzato, di epoche e luoghi portatori di spirituale ricchezza.
Il filosofo sottolinea quale formidabile balzo in avanti nello sviluppo dei procedimenti razionali, nel possesso raziocinante del mondo abbia rappresentato la Rivoluzione scientifica, a quali autentiche problematiche poste dalla convivenza sociale abbiano cercato di rispondere i filosofi del Settecento e un padre del pensiero liberale come Benjamin Constant: dunque, nessun ritorno all’indietro, nessuna critica antiscientifica, a meno che non ci si voglia condannare alla sterilità del rimpianto, ma, piuttosto, l’acuta consapevolezza della frattura avvenuta e della conseguente amputazione, perché è indispensabile avere una lente non banale con cui leggere il funzionamento effettivo del mondo della tecnica e delle merci.
Consapevolezza anche della necessità di trascenderlo, quindi di aprire varchi attraverso il grimaldello di una nuova metafisica capace di misurarsi, diversamente dalle tradizionali, con lo scenario plasmato dalla razionalizzazione irrazionale, una metafisica immanentistica e razionale imperniata sulla centralità della qualità (determinazione che si sottrae alla contabilità) e del limite che si oppone al cattivo infinito quantitativo.
Questa parte conclusiva del lavoro di Bontempelli, con i suoi riferimenti ad Heidegger e ad Hegel, da un lato è sicuramente di approccio più arduo per un liceale ed un lettore non specialista della disciplina, dall’altro però suona come un’inderogabile affermazione di possibilità di resistenza all’universalizzazione di tecnica e merci che nutre la speranza di quanti non ritengono tale universo un destino.
Resistere ai richiami delle sirene delle ultime novità tecnologiche, interrompere il ciclo produzione-consumo, adottare ritmi di vita lenti, rifiutare le manipolazioni sui corpi biologici rappresentano opzioni a favore di un ristabilimento di un equilibrio antropologico che si è smarrito in una deriva che da una parte esibisce i tratti della frenesia efficientistica, cumulativa ed utilitaria, dall’altro quelli della resa al nichilismo, facce apparentemente discordi di una stessa medaglia: una vita mutilata, circoscritta entro le regole dettate dai mezzi promossi a fini, privata di scopi intrinseci ed orizzonti di senso, di bene in definitiva.
Affermare la conoscibilità del bene, dunque la sua razionalità, riportare l’etica al centro del discorso filosofico per correggere le storture di una ragione impoverita che si identifica con il calcolo è operare una scelta per la vita, per tutto quanto promuove un progresso di umanità. È questo il dono – gravido di promesse, ma anche di tenace impegno – che Massimo Bontempelli ha lasciato a coloro che, sulle soglie dell’esistenza adulta, sono chiamati a fare il loro cammino di umani, a contribuire con le loro azioni ad accrescere la vita universale e ad averne cura.
Il progetto che ha coinvolto alcuni professori e studenti del Liceo Classico “Galileo Galilei”di Pisa, dove Bontempelli ha a lungo insegnato (con l’istituzione del «Premio di Filosofia Massimo Bontempelli» giunto alla sua XIIa edizione, le considerazioni delle insegnanti che hanno guidato l’esperienza, ed in particolare – ciò che è davvero importante – quanto scrivono gli studenti nella loro recensione al libro, ed infine le espressioni di Lucio Bontempelli – figlio di Massimo), tutto ciò1 rappresenta un segnale incoraggiante in questa direzione, una prova tangibile che la sua voce divergente è capace di spezzare silenzi e di suscitare echi, corrispondenze e nuove suggestioni.
Urbino, maggio 2025
Fernanda Mazzoli
1 Cfr. Appendice al libro, pp. 155 ss.
|